Un intervento di riqualificazione energetica spesso contrasta con la possibilità di isolare dall’esterno le pareti perimetrali dell’edificio. In presenza di vincoli per edifici storici, facciate in mattoni a vista, vincoli sulle distanze dai confini e interventi parziali sull’edificio, la soluzione migliore per la coibentazione è rappresentata dall’isolamento termico dall’interno o in intercapedine.

Nel caso di isolamento termico della parete dall’interno, le comuni tecniche costruttive prevedono la posa in opera di pannelli isolanti e della barriera al vapore sul lato caldo dello stesso. Spesso viene anche realizzata una controparete interna di finitura in muratura o in lastre.
La barriera al vapore, che consiste in uno strato di materiale impermeabile, rappresenta una protezione per l’isolante impedendo teoricamente la formazione di condensa negli strati interni.
La posizione della barriera al vapore dipende dal flusso di calore e quindi di vapore e, generalmente, viene posizionata sul lato caldo del pannello isolante. Tuttavia, l’impiego della barriera al vapore è una questione molto dibattuta tra gli esperti. In alcune situazioni, ad esempio in estate, nel caso di inversione dei flussi igrometrici o nel caso di posa in opera errata, la barriera al vapore può costituire un ostacolo al corretto funzionamento dell’involucro edilizio, oltre a compromettere la traspirabilità della parete.
E’ possibile evitare l’utilizzo della barriera al vapore in caso di isolamento termico dall’interno?
La formazione di condensa interstiziale e superficiale è un rischio presente sia negli edifici di nuova costruzione che negli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti e deve essere verificata nel rispetto della normativa di riferimento.
Il calcolo predittivo, in accordo con la norma UNI EN ISO 13788, ha come scopo la determinazione della temperatura superficiale interna minima dei componenti edilizi, al fine di evitare il rischio di condensa superficiale e interstiziale, per valori prefissati di temperatura e umidità relativa interna (metodo di Glaser).
Questo metodo tuttavia ipotizza alcune importanti semplificazioni, quali l’assenza di umidità da costruzione negli strati e non tiene conto di alcuni importanti fenomeni fisici quali la dipendenza della conduttività termica dal contenuto di umidità, la risalita capillare e il trasporto di acqua liquida all’interno dei materiali, la variazione delle proprietà dei materiali in funzione del contenuto di umidità e la capacità igroscopica dei materiali.
I limiti del modello di Glaser sono evidenti, poiché essendo un modello di calcolo semplificato, assume che le condizioni al contorno siano costanti e non considera aspetti presenti nelle situazioni reali.
Per ovviare ai limiti del modello di Glaser è possibile studiare il fenomeno dell’umidità nelle strutture in regime variabile in accordo con la più recente normativa di riferimento UNI EN 15026.
A differenza del metodo di Glaser, questa nuova metodologia tiene conto di diverse problematiche quali l’influenza dell’irraggiamento e della pioggia sulla migrazione del vapore, i fenomeni legati all’asciugatura delle strutture e il comportamento dell’utenza.
L’analisi in regime variabile consente di distaccarsi dalla valutazione media mensile e di valutare il fenomeno della condensazione nella sua complessità, anche per brevi intervalli di tempo.
Con l’ausilio di software specifici, in accordo con la norma UNI EN 15026, è possibile realizzare simulazioni igrometriche orarie, sulla base delle caratteristiche intrinseche dei materiali. Le informazioni di partenza per la simulazione devono essere pertanto più raffinate rispetto a quelle comunemente usate nel modello di Glaser, perché comprendono dati su diversi parametri quali la capacità di assorbimento dei materiali, la variazione delle caratteristiche di conduttività termica e resistenza al vapore in funzione del contenuto di umidità e il coefficiente di trasporto d’acqua.
Mettendo a confronto i due modelli di calcolo tramite una simulazione si riscontrano differenze sostanziali nei risultati ottenuti.
Prendendo in esame un intervento di riqualificazione energetica, che prevede l’isolamento dal lato interno della parete con pannelli minerali in idrati di silicato di calcio, è possibile sottoporre la parete ad analisi della condensazione sia con il metodo di Glaser che in regime variabile.
Si tratta di un caso tipico in cui il modello predittivo della UNI EN ISO 13788 (Glaser) indica un’abbondante formazione di condensa interstiziale, da correggere con l’inserimento di una barriera al vapore, mentre il modello predittivo in regime variabile della EN ISO 15026 non prevede problemi di condensazione, in accordo col comportamento reale della stratigrafia.
L’analisi in regime variabile, infatti, mette in evidenza la capacità igroscopica dei materiali della stratigrafia e la capacità di accumulo e rilascio di umidità dell’isolamento interno, in particolare del pannello minerale in idrati di silicato di calcio. Il pannello minerale utilizzato nell’intervento assicura l’isolamento termico della parete ed evita l’inserimento della barriera al vapore, garantendo la naturale traspirabilità della parete.
Qui puoi scaricare un report dettagliato sull’analisi igrometrica in regime variabile di un caso reale con isolamento interno senza barriera al vapore.
Guarda l’anteprima gratuita del corso sulla corretta progettazione dell’involucro edilizio


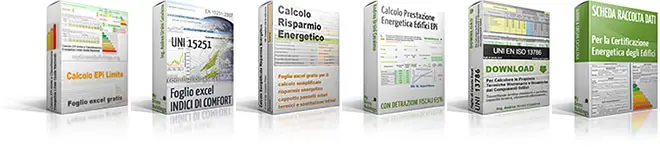
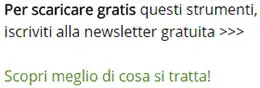






Ciao Andrea,
interessante l’argomento trattato, non se ne parla mai abbastanza e soprattutto non lo si insegna mai abbastanza.
Quando si parla di barriere al vapore, si scatena il finimondo da parte dei puristi per le nuove costruzioni e/o risanamenti eco-compatibili.
Quelli che vogliono costruire con le balle di paglia e i mattoni prodotti con fango e paglia e cotti al sole. I quali predicano e scrivono a destra e a manca che i materiali devono respirare e che la traspirazione ci deve essere anche dall’interno all’esterno
e viceversa.
Io la penso e realizzo completamente diverso:
– l’interno deve essere separato da quello che succede all’estreno, perturbazioni atmosferiche, umidità, inquinamento etc. ;
– applico una vera barriera al vapore tra la massa interna (scambiatore termico) e l’isolazione esterna ;
– il sistema costruttivo deve consentire il mantenimento dei materiali senza alterazioni esterne di nessun genere, e l’ambiente interno deve essere sano, salubre.
Per fare questo utilizzo un sistema costruttivo alternativo, stratificato utilizzando inoltre le camere ventilate gestite, nelle fondazioni, pareti di elevazione esterne e coperture sia a falde che piane (vedi sezione tipica con camere ventilate gestite : chiuse in inverno e aperte d’estate).
Personalmente sono un sostenitore della barriera al vapore per quanto riguarda le nuove costruzioni e i risanamenti esterni, dove si possono applicare.
La mia prima barriera al vapore l’ho applicata in un progetto a Dortmund (Germania) , per un edificio amministrativo di una grande azienza immobiliare. Dove tra l’altro avevo applicato anche un rivestimento di facciata coibentato e ventilato, erano gli anni 1970, precisamente nel 1972, ancora oggi i risultati sono eccellenti. Mi ricordo ancora che la fornitura della guaina era stata della ditta Brass, spessore 2 mm, mettemmo in atto questo grande preservativo sull’edificio, tagliando la parte sui fori finestre e facciate dell’edificio. A quel tempo non si parlava di certo di barriere al vapore, ma fu una intuizione eccellente.
Per i risanamenti interni invece non è così scontata la presenza della barriera a vapore, vuoi per la non conoscenza del problema, vuoi per la non conoscenza dei materiali a disposizione da utilizzare al meglio.
Personalmente non mi fermerei solo all’isolazione interna con i materiali innovativi per l’italia (pannelli minerali con idrati di silicato di calcio), non certo per la Germania, che li utilizza già da molti anni.
Farei un passo avanti, userei dei prodotti già in uso in Germania, che fanno parte di un sistema collaudato per le costruziuoni, dalle case di civile abitazione ai capannoni industriali, forniti dalla YTONG, GREISEL, HEBEL, che utilizzano il calcestruzzo cellulare, struttura porosa a cellule chiuse (80% aria e il 20% in solido : sabbia quarzifera, calce e cemento bianco), in Italia viene paragonato al CALCESPAN, ma non è lo stesso prodotto.
Questo perchè, si può fare comunque isolazione ma si aggiunge anche la massa (scambio termico), che ritengo sia altrettanto importante per un risparmio energetico sostanzioso e per un vivere sano e salubre.
Questo in sintesi!
Saluti, Toribio
Ciao a tutti dovrei realizzare una stanza su un terrazzo e realizzare la struttura in tubolare metallico.Domanda come dovrei costruire le mie pareti isolando sia acusticamente che termicamente ?. E il tetto grazie.
Ciao, potresti utilizzare una tamponatura in blocchi di calce e canapa.
Buongiorno Andrea,
Sto ristrutturando una vecchia casa con pareti in sasso nero (basalto) a vista con muri spessi circa 60 cm. Con il termotecnico si è deciso di fare un cappotto interno per rendere la casa più efficiente sotto l’aspetto energetico. Spiego le operazioni e successivamente il problema:
Il muro dalla parte interna è stato rinzaffato con un getto di cemento per dare consolidamento al muro e legare bene i sassi, poi è stata applicata una lastra di lana di roccia da 8 cm, barriera vapore, altra lana di roccia da 4 cm e lastra in cartongesso. Sono state siglillate bene tutte le finestre con pannelli in xps per evitare ponti termici, il tutto con una attenzione particolare a non danneggiare la barriera. I serramenti non sono ancora montati perchè i lavori proseguono, ma mi sono accorto con i primi caldi che sulla barriera vapore si sta creando condensa. Tutti mi dicono che è normale asciugatura del muri dovuta alle lavorazioni e perchè l’interno casa non è riscaldato, io però sono molto preoccupato, non vorrei che negli anni il problema aumentasse a dismisura. Sono in balia di esperti e tecnici e non riesco a farmene una ragione, sono preoccupato anche per i travi in legno che, essendo infilati nel muro, sono a contatto con l’acqua.
Mi potresti dare la Tua opinione a riguardo?
Grazie anticipatamente.
Luca
Ciao Luca, la barriera al vapore, come dice la parola stessa, ha il compito di frenare o fare da barriera al passaggio del vapore, in questo caso verso l’esterno, per impedire che questo possa accumularsi nello strato isolante e, nel tempo, rovinarlo. Quindi se vedi umidità sulla barriera, è normale. Il sistema deve poi essere in grado di smaltire l’umidità formatasi durante le stagioni più calde.
Con la configurazione stratigrafica che mi hai illustrato, potresti avere problemi di marcescenza dei pannelli in lana di roccia per due motivi:
1. la barriera al vapore va messa sul lato caldo dell’isolante, quindi sul lato più interno rispetto a tutti gli strati di isolamento termico. Nel tuo caso andrebbe messa tra il pannello in cartongesso e quello in lana di roccia.
2. il rinzaffo in cemento non ha una grande permeabilità al vapore, per cui potrebbe frenarlo e nel tempo creare problemi alla lana di roccia. Sarebbe stato meglio un rinzaffo in calce naturale, molto più traspirante del cemento.
La resistenza al passaggio del vapore di una parete andrebbe progettata in modo che essa diminuisca gradualmente dall’interno verso l’esterno, in modo da non creare dei freni intermedi al vapore, che stazionerebbe e creerebbe problemi agli isolanti termici fragili all’umidità.
In questi casi è sempre meglio progettare la stratigrafia, quando possibile, mediante un’analisi igrometrica in regime dinamico (vedi WUFI).
Nel tuo caso, molto probabilmente io avrei optato per un isolamento termico interno in calce e canapulo, materiale isolante naturale altamente performante rispetto all’umidità ed evita la posa di una barriera al vapore. Se scarichi il documento tecnico consigliato dall’articolo sopra, potrai approfondire meglio la questione.
Grazie Andrea per la risposta.
Mi volevo correggere su un punto, ho chiesto ai muratori e il rinzaffo è stato fatto in calce naturale con una piccolissima percentuale di cemento. Il mio problema non è solo l’isolamento ma il fatto che non ho fatto di testa mia ma ho pagato un termo tecnico che mi ha fatto lo studio e la stratigrafia del muro con tutti i calcoli necessari e come posare il tutto. Ormai sono giorni che ci penso e mi sto convincendo che forse un freno vapore subito dopo la lastra di cartongesso sarebbe stata la soluzione più indicata, anche se tutte le lastre di casa sono Hydro (Fassa Bortolo Lignum). La rabbia è che ho pagato fior di quattrini per architetto e termo tecnico e non mi sanno dare risposte, finirò per fare di testa mia.
Ti ringrazio molto per la risposta chiara e la professionalità, ora cercherò di sistemare in qualche modo anche se sarà dura togliere tutte le lastre con impianti fatti e massetto fatto…meno male che non ho stuccato le lastre!
Luca
Dimenticavo che è in programma di installazione anche la VMC in casa, non so se può influire sulla decisione finale.
Grazie ancora, Luca
Ciao la VMC un po’ aiuta, si.
In conclusione, muro di sasso con rinzaffo in calce, 12 cm di lana di roccia, freno vapore e lastra Gypsolignum Fassa bortolo con aggiunta di VMC…così me la dovrei cavare giusto?
Grazie Luca
Esatto, dovresti farcela!
Grazie infinite, sei l’unico che mi ha aiutato seriamente.
Luca
Ciao Andrea,
vivo in svizzera (ticino) e coome Luca qui sopra mi appresto a ristrutturare una vecchia casa in sasso da 60cm utilizzata ad oggi come casa di vacanza.
I muri in sasso sono stato rinzaffati in cemento e pitturati. Vorrei Fare un cappotto termico interno per le pareti perimetrali ma nessuno sembra avere le idee in chiaro….
Essento una casa vecchia le stanze sono piccole e quindi i cm a disposizione non sono molti. io pensavo di utilizzare pannelli multipor ma in bagno avrei problemi visto che mi sembra di aver capito che non siano “piastrellabili”. Hai quanleche consiglio da darmi?
ti ringrazio in anticipo…
Giancarlo B.
Ciao Giancarlo.
Il rinzaffo in cemento è stato fatto dall’interno?
Qual è lo spessore massimo si cappotto che potresti sacrificare all’interno?
Bungiorno, sono molto interessato all’argomento perché vivo in un appartamento in edificio anni 60/70 al IV piano e in più, una parete per camera da letto, purtroppo, espone a nord. Il risultato è che le pareti di perimetro nord, circa metri 12 lineari, oltre ad essere sempre fredde, nel periodo invernale riaffiorano delle muffe. Purtroppo ad ogni ditta che chiedo come risolvere, ogni una ha la sua teoria. Allora, magari sbagliando, sto cercando di documentarmi e trovare da me una soluzione, premetto che sono solo un amante del fai da te, infatti vorrei proporre a lei la mia idea e nel caso non fosse così strampalata far eseguire i lavori da un operaio, sotto le mie indicazioni. Premetto che abito a Palermo dove il clima è risaputo non è molto freddo ma piuttosto umido:
Passo 1)
Vorrei trattare la superficie muraria con un prodotto dal nome Muffa K.O. della Tecnostuk, esso si dice che sia un battericida in crema, da dare con pennello, e servirebbe per sanificare e uccidere le spore.
Passo 2)
Creare sul muro 2 fori di ventilazione fino all’esterno.
Passo 3)
Creare una parete in cartongesso adiacente alla parete (malata) ma con una intercapedine vuota di circa 5 cm, così i fori di areazione farebbero un ricircolo d’aria.
Passo 4)
Creare la struttura portante in alluminio per cartongesso e inserire, tra i montanti, dei pannelli in lana di roccia da 5 cm per , poi, applicare i pannelli in cartongesso idrofughi.
Passo 5)
Ovviamente rasare, stuccare e infine pitturare con una pittura termoisolante.
Secondo la sua esperienza potrebbe essere la soluzione, considerando che esternamente, vivendo in uno stabile, non posso intervenire?
Ringrazio anticipatamente del tempo che mi dedicherà
Dr Alessandro Migliore
Ciao e grazie per l’interesse.
Lascia stare fori nel muro, cartongesso ecc.
L’unica soluzione efficace che ti consiglio è la seguente:
1) pulisci bene la superficie con un raschietto
2) trattamento antimuffa della parete mediante sali di boro diluiti in acqua al 10-15%, un paio di mani a pannello e lasci asciugare
3) termointonaco in calce-canapulo, almeno 5 cm di spessore
4) rasatura a calce naturale
5) se vuoi, tinta calce naturale
Gent.mo Andrea,
scrivo per chiedere un parere viste le risposte discordanti che ho ricevuto da tecnici differenti in merito alla realizzazione di una coibentazione su muratura esistente.
In questa ristrutturazione, di fatto un sopralzo, ci troviamo ad avere un lato dell’edificio (sud) nel quale i muri confinano nella parte bassa con il sottotetto non riscaldato del vicino e nella parte più alta sporgono dal tetto del vicino stesso ed sono esposti all’aria esterna; in questa porzione esterna è stato realizzato, su concessione del vicino confinante, un cappotto in eps con grafite e rasatura di 5 cm che va a chiudere in battuta sul tetto in laterizio confinante.
Ora stiamo cercando di capire, volendo eseguire anche una coibentazione interna che possa rivestire tutti i muri nella loro altezza, quale sia la migliore soluzione per evitare condense pericolose.In una porzione delle murature è previsto l’utilizzo di fibra di legno da 8 cm con una controparete in cartongesso; nelle altre zone, per problemi di spazio interno, si pensava ad una lastra in cartongesso accoppiata ad un materiale isolante.
secondo lei è corretto posizionare una barriera vapore ed in quale posizione oppure non mettere nulla o ancora utilizzare una membrana igrovariabile?
grazie
Paolo
Ciao l’unico modo per capire se utilizzare una barriera o freno al vapore e di che tipo è fare una valutazione analitica sul flusso di vapore che attraversa la parete, in regime semistazionario o meglio ancora dinamico. Detto questo, volendo abbozzare una soluzione, laddove possibile andrei con un termo-intonaco in calce e canapa, senza barriera al vapore.
Buonasera,
dovrei coibentare il soffitto in laterocemento di un piano intermedio. Tenendo presente che il pieno superiore, una mansarda, è spesso disabitata, avevo pensato di aumentare il più possibile lo sfasamento termico introducendo un controsoffitto in cartongesso riempito di pannelli di fibra di legno da 160 kg/mc spessi 14 cm. Leggendo qua e là mi è venuto il dubbio che per non vanificare il potere coibentante della fira di legno sarebbe necessario inserire anche una barriera vapore subito sopra il cartongesso. Di contro ciò un po’ mi preoccupa, perché ho sempre pensato che i muri dovessero poter traspirare, in particolare d’estate.
Cosa mi consiglia?
grazie
cordiali saluti
Lorenzo Caffo
Ciao Lorenzo, nel tuo caso non dovresti avere problemi con la barriera al vapore.
Occorre probabilmente una valutazione del rischio condensa interstiziale più accurata, mediante analisi in regime dinamico (UNI EN 15026).
Salve Ing,
cercherö di fornire piü info per una minima soluzione al problema.
Avrei bisogno di un consiglio su come coibentare termicamente dall’interno il tetto composto da una gettata di calcestruzzo con sassolini sp.20 cm di una garage in muratura esterno all’abitazione, zona pianura veneta.
Essendo l’intervento in spessori minimi non mi aspetto risultati da manuale (sfasamento)ma solo pur un limitato miglioramento (la finitura estetica non ha importanza).
Note: Il locale ha una porta con finestra che lascio aperta di notte in estate. Detto locale (le cui pareti laterali sono isolate acusticamente)rimane freddo d’inverno ovvero riscaldato minimanente per poche ore mentre all’estate e’ prevista l’installazione di un condizionatore che accenderö 5 ore al giorno(ore centrali e la sera)
Esternalmente il tetto e’ un terrazzo calpestabile e ha uno strato di impermeabilizzante dato a pennello (eventualmente potrei solo intervenire all’esterno con posa di guaina piü 2-3 cm di eps piü massetto 3cm )
Internamente il soffitto ha un eps ad incastri di 3 cm NON incollati ma posati lasciando 1 cm di aria (ERRORE in quanto si forma condensa all’estate, tanto da aprire alcuni di questi pannelli ed arieggiare)
I miei dubbi di posa interna:
A)incollare questo EPS da 3cm maschiato (parametri termici eccellenti) al soffito e lasciarlo a vista ed eventualmente mettere un compensato con interposta barriera vapore (giä comunque l’EPS e’ una barriera al vapore…)
B) incollare sughero da 4 cm (parametri termici ottimi con eccellente traspirabilitä) a vista oppure completare il sughero con un “freno al vapore” (traspirante tipo Intello)piü compensato di finitura.
C)lana di vetro-roccia (paramentri simili al sughero)con barriera di allumnio appoggiata la soffitto su un telaio (credo perö possa presentare problemi in quando probabilmente a contatto con il tetto caldissimo a seguito dello scambio termico potrebbe bagnarsi,ammuffire e perdere le qualitä d’isolamento…generalmente si presta piü al montaggio su pareti laterali piü sandwich cartongesso + gommapiombo per isolamento acustico)
Grazie,
Fabrizio
Ciao Fabrizio, io andrei con il sughero incollato e rifinito con rasante/tinta base calce, senza barriera al vapore.
Salve ingegnere
Ho un edificio unifamiliare in zona climatica C non coibentato, mi appresto ad eseguire una parziale ristrutturazione, le pareti perimetrali sono costituite da doppio strato di mattoni forati con intercapedine di circa 10 centimetri ed in questo caso avrei pensato di procedere al riempimento con granuli di sughero, considerando.che è un prodotto naturale e che offee anche una buona protezione dal calore estivo, poi ho delle stanze al secondo piano il cui soffitto è sovrastato da un terrazzo pavimentato, in questo caso pannelli in sughero dello spessore adeguato (10 cm?) ricoperti da controsoffitto in cartongesso, cosa che farei anche in mansarda dove il tetto in laterocemento con tegole non è isolato (o potrei all’estradosso rimuovendo la copertura)
Le chiedo gentilmente un parere sul tipo di isolante “sughero” , lo spessore consigliato e sul rischio di formazioni di condense potenzialmente pericolose soprattutto per quanto riguarda il soffitto, se necessita o meno dell’utilizzo di una barriera al vapore, considerando anche la traspirabilità dell’isolante usato e dato anche che la barriera non potrebbe essere inserita nell’intercapedine
Grazie mille
Salve il sughero potrebbe andare bene, ma per rispondere sarebbero necessari dei calcoli e delle verifiche termoigrometriche. Non è possibile rispondere correttamente su due piedi. Detto questo, molto probabilmente avrà bisogno di uno spessore di isolante al soffitto più elevato (per i limiti di legge) e forse potrebbe fare a meno di una barriera al vapore.