La gestione di un impianto di riscaldamento a pavimento radiante diventa estremamente semplice se si pensa che alla base del suo funzionamento insiste il concetto di attivazione della massa termica.
La massa termica di riferimento nel caso specifico è la superficie del rivestimento superiore che si comporta come un grande radiatore avente una superficie di emissione pari a quella dell’ambiente riscaldato.
Diversi lettori pongono delle questioni sul riscaldamento radiante a pavimento. Ho raccolto qui le risposte alle domande più richieste, cercando di rendere utili anche a te queste informazioni.

Queste sono le domande più frequenti (hai altre domande?):
- Come gestire al meglio un pavimento radiante e la regolazione della temperatura?
- Come regolo i flussometri sul collettore?
- Come gestisco l’impianto a pavimento se non dispongo del progetto dell’installatore (e quindi non so quanto sono lunghi gli anelli, che passo hanno, che portata dovrebbero avere, qual è la potenza termica di ciascuno)?
- Come gestisco l’impianto se ho una caldaia centralizzata (condominio) e ogni appartamento ha il suo conta-calorie? (Cambia qualcosa dalla situazione in cui ho la caldaia autonoma?)
- Che differenza c’è fra l’avere la sonda esterna che decide la temperatura di mandata e non averla?
Come Gestire al Meglio un Pavimento Radiante e la Regolazione della Temperatura?

La migliore gestione dell’impianto a pavimento radiante dal punto di vista del comfort ambientale è la realizzazione di due zone termiche a diversa temperatura controllabile: zona giorno e zona notte.
Il controllo della temperatura in ciascuna zona può eseguirsi per mezzo di un semplice termostato ON/OFF che chiude in contatto elettrico su di un attuatore elettrotermico normalmente chiuso posizionato sulle circuitazioni di mandata di ciascun locale.
In questo modo si possono regolare due diverse zone a temperatura differenziate, anche se di valore operante diverso (20°C zona giorno, 17°C zona notte).
Affinchè il comfort abitativo non subisca variazioni a causa della riduzione notturna, è suggeribile mantenere l’impianto in una condizione di esercizio continuativo, diversamente per quanto concepibile con corpi scaldanti tradizionali soggetti a pendolazioni di funzionamento.
Come Regolo i Flussometri sul Collettore?

I flussometri posizionati sul collettore di mandata della cassetta di distribuzione vanno regolati secondo le condizioni al contorno dell’impianto da dimensionare.
In particolare, nota la temperatura ambiente da raggiungere e le dispersioni globali dell’ambiente da climatizzare, si esegue quella che viene definita taratura dell’anello sulla base della portata volumetrica richiesta per soddisfare la condizione di temperatura prevista.
Tale procedura si esegue regolando in litri/minuto il flussometro indipendentemente dalla sua scala di taratura. La medesima operazione si esegue su tutti gli anelli consentendo così di bilanciare l’impianto per le portate di progetto previste a fronte delle temperature richieste.
Qualora non si proceda alla suddetta procedura, si correrebbe il rischio di non bilanciare l’impianto ai carichi termici richiesti creando così delle zone di temperatura in eccesso causate da portate superiori e zone di temperatura in difetto a causa di scarse portate (secondo le portate di progetto).
Come Gestisco l’Impianto a Pavimento se non Dispongo del Progetto dell’Installatore (e quindi non so quanto sono lunghi gli anelli, che passo hanno, che portata dovrebbero avere, qual è la potenza termica di ciascuno)?

Senza un disegno esecutivo redatto in prima emissione da un progettista e adeguato poi alle lunghezze di posa eseguite, la procedura di taratura diventa meno tecnica e più empirica in quanto mancano le informazioni legate alle portate di progetto.
A questo punto, supponendo che la portata di progetto sia sufficiente in ingresso alle zone da collettore, anello per anello si parte da una posizione iniziale di completa apertura del circuito e si comincia a chiudere finchè la differenza di temperatura tra mandata e ritorno non sia superiore ai 7-10°C.
In questo modo il metodo empirico si avvicina a quello tecnico, ma con grande approssimazione se non ci sono informazioni di riferimento nemmeno sul passo di posa della distribuzione.
In tal modo però, la taratura dei collettori e quindi degli anelli non prevede la corretta calibrazione della temperatura ambientale.
Come Gestisco l’Impianto di Riscaldamento a Pavimento Radiante se Non Ho una Caldaia Autonoma, ma Centralizzata (condominio) e ogni Appartamento Ha il suo Conta-Calorie? (Cambia qualcosa dalla situazione in cui ho la caldaia autonoma?)

La gestione del pavimento radiante in presenza di un impianto centralizzato e non autonomo, dipende dalla configurazione del controllo remoto posizionato in ogni singola unità abitativa (se esiste).
In ragion di questo anche un impianto radiante di tipo centralizzato può essere ottimamente gestito se anche la produzione di calore da parte del generatore segue le caratteristiche dell’impianto.
In particolare l’impiego di generatori di calore con campi di modulazione di potenza su intervalli di temperatura 20 – 80 °C consente di adeguare il carico termico della caldaia al fabbisogno dell’impianto.
In questo modo il rendimento di emissione globale stagionale risulta, per gestione delle temperature e dei carichi termici nel transitorio del periodo stagionale, più elevato.
L’impiego di un conta calorie o misuratore di portata volumetrica non aumenta e non interviene direttamente in alcun modo sull’efficienza dell’impianto quanto piuttosto sul consumo specifico di ogni singola unità.
Che Differenza c’è fra l’Avere la Sonda Esterna che Decide la Temperatura di Mandata e Non Averla?

La gestione dell’impianto radiante (anzi di qualunque impianto termico) attraverso l’impiego di un sensore di temperatura esterna diventa fondamentale allo scopo di ottenere la giusta quantità di calore quando serve nei vari periodi dell’anno.
In particolare la regolazione che usa tecniche REM non ha solo l’obiettivo di adeguare i carichi termici alle condizioni di temperatura esterna, ma anche quello di ottimizzare, sulla base delle temperature desiderate all’interno degli ambienti, anche un consumo di combustibile fossile da parte delle utenze.
Hai altre domande o indicazioni da condividere? I tuoi commenti sono ben graditi.
Approfondimenti
- Guida alla Progettazione di Impianti di Riscaldamento a Pavimento Radiante
- Impianti di Riscaldamento: Regolazione e Manutenzione degli Impianti Termici Autonomi per Risparmiare Energia
- La Regolazione degli Impianti di Riscaldamento e Climatizzazione. Componenti, Parametri Funzionali, Schemi
- Impianti di Riscaldamento. Guida alla Progettazione del Sistema Edificio-Impianto
A cura di Ing. Gennaro Vietri
Photo credit: donna-andrew, Joel Kramer, moppet, selkovjr, Richard Ash, hukseflux


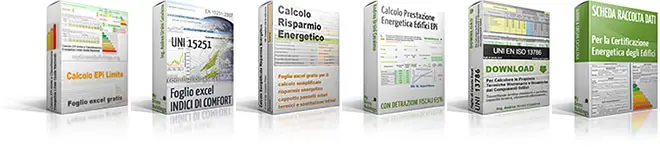
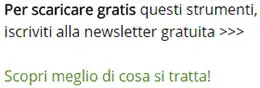




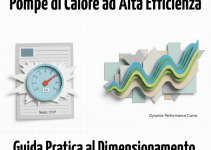

Limitando il commento ai sistemi radianti a pavimento, vorrei porre l’accento su due questioni fondamentali:
1) emissività della superficie radiante. È opportuno non utilizzare materiali a bassa emissività, in pratica occorre usare superfici opache, altrimenti l’effetto radiante si abbassa notevolmente;
2) tenere in conto della EFFETTIVA superficie radiante disponibile. Troppo spesso ambienti dotati di pavimento radiante vengono occupati da mobilio e tappeti che ne annullano l’effetto.
Un proposito per il nuovo anno 2013: focalizziamo la nostra attenzione verso soffitti e pareti radianti (caldi e freddi), a mio modo di vedere molto più funzionali e flessibili. Auguri a tutti.
Ciao Massimo e grazie per le informazioni!
Perché trattarli soltanto come “impianti di riscaldamento” e non anche come “impianti di raffrescamento”? (sempre a pannelli radianti): quali ne sarebbero le necessità e quali le opportunità?
E’ necessario risparmiare ormai anche e soprattutto in estate.
Perché non mettere in evidenza che la temperatura del liquido in circolo (non necessariamente acqua – che potrebbe gelare in montagna-) nel caso degli impianti di riscaldamento potrebbe essere sufficiente quella prodotta dai pannelli solari e che soltanto in pochi casi, durante l’anno, dovrebbe essere integrata da altra fonte, con necessità conseguente di una centralina ad hoc?
Personalmente preferisco installarli solo come impianti di riscaldamento perché usarli anche come raffrescamento necessita di installazione di altre macchine e quindi di altri spazi da ritrovare oltre ad un sistema di deumidificazione interna. A questo punto credo che i costi di gestione e prima ancora di installazione siano controproducenti.
Sempre a mio parere, è invece ottima, la possibilità di integrare varie fonti di calore per riscaldare l’impianto a pavimento.
Io in più casi ho montato come fonte principale una stufa a pellets associata a termocamino, dove possibile insieme a pannelli solari forniti di boiler con resistenza interna.
A proposito del raffrescamento estivo per mezzo di pannelli radianti a pavimento, cosa ne pensate di un fluido vettore che riceva l’abbattimento termico dal terreno prima di immettersi nell’involucro da raffrescare?
Le tubazioni posate nel terreno dovrebbero però essere di materiale metallico per la rilevante conducibilità rispetto materiali sintetici quali PE o PVC. Questo vale anche per raffrescamento tramite aerotermia.
Gildo Morelli
Nell’ambito del mio lavoro sono parecchi quelli che criticano questo sistema (del riscaldamento a pavimento) perchè, dicono, solleva polvere e riscalda in modo innaturale.
A me non sembra che succeda, né l’uno né l’altro degli inconvenienti e io a casa mia lo vorrei (e purtroppo non ce l’ho).
Giovanni, l’utilizzo estivo é senz’altro interessante benché limitato nella potenza radiante e con la necessità di gestire il pericolo di condensa oltre che l’umiditá ambiente.
Comunque, aspettiamo che Andrea ne voglia parlare e parteciperemo senz’altro alla discussione.
Ciao, Massimo.
Concordo con Massimo Enei a proposito dei soffitti e delle pareti, ma il costo di questi non li rende facilmente fruibili sulla cantieristica diventando, di fatto, prodotti per pochi intimi.
Complimenti per le rubriche pubblicate e auguri di buon anno.
Grazie Andrea per le email che puntualmente ricevo.
Ho da poco installato pannelli radianti a pavimento su una nuova abitazione e ho notato due difetti:
il primo è che nella zona notte dove ho messo del parquet le stanze risultano più fresche forse perchè il legno è più isolante, quindi lo sconsiglierei con i pannelli radianti, il secondo è che un scaldasalviette in bagno non si riscalda, in quanto la temperatura dell’acqua dei pannelli radianti non supera i 40 gradi.
Saluti Paolo
Ciao Massimo, se vuoi introdurre e parlare il discorso estivo sei il benvenuto!
Magari puoi scriverci un articolo che poi pubblico a tuo nome qui su MyGreenBuildings.
Radiante a soffitto (caldo o freddo). Lasciamo perdere la cantieristica…..
Pensiamo alla ristrutturazione e a quanto sia più semplice abbassare il soffitto di qualche cm piuttosto che sventrare un pavimento. Inoltre il leggero minor comfort derivante dal caldo dall’alto è ampiamente bilanciato da: maggior resa radiante (gesso vs. ceramica); ridotto tempo di messa a regime; possibilità di uso estivo; ecc.
A Paolo. Il parquet ha un minor “k” quindi la temperatura di pelle normalmente è più bassa. Se puoi, prova ad aumentare la temperatura dell’acqua in quella zona.
Accetto l’invito di Andrea e proporrò un articolo per l’anno nuovo.
Buon Anno 2013 a tutti.
Massimo
Buongiorno e Buon Anno a tutti voi e, in particolare, ad Andrea per l’utilissimo sito che offre.
Vorrei esporre dei miei pensieri sulla progettazione termica per raccogliere delle vostre critiche.
Parliamo di una casa a due piani. Piano terra con rivestimento a ceramica: il riscaldamento a pavimento è il più votato perché il calore è uniforme su tutto il pavimento; i moti convettivi sono minimi e, quindi, non spostano la polvere (come fanno i termosifoni). Ma c’è il problema che non si conosce l’arredamento e, quindi non lo si ottimizza. Pensavo al soffitto radiante, ma c’è il problema della stratigrafia rovesciata, ovvero che la zona a pavimento è più fredda della zona a soffitto. Il riscaldamento a parete non lo considero perché non conosco l’arredamento.
Piano primo con rivestimento in legno: non vorrei considerare il riscaldamento a pavimento, perché, per ottenere una certa temperatura (diciamo 18°), devo consumare di più, in quanto ho un pavimento che mi isola (legno). Il riscaldamento a soffitto non lo considero per il motivo prima citato. Mi rimangono i termosifoni, che sceglierò in alluminio perché funzionano a bassa temperatura, in coerenza con il riscaldamento a pavimento al piano terra (così ho una caldaia a condensazione standard). I moti convettivi DEVONO essere minimi; quindi mantengo SEMPRE acceso l’impianto, con la conseguenza che la caldaia si accende e si spegne spesso, ma per poco.
Questo è il mio ragionamento che, desidero vogliate criticare.
L’unico fattore comune per tutte le soluzioni è che l’involucro DEVE essere isolato il più possibile.
P.S.: continuo a pensare ad una integrazione con i pannelli solari termici (sono consulente di pannelli sferici per il Veneto), ma mi hanno sempre detto che non possono sostituire completamente la caldaia; altra alternativa è il termocamino (stube, ollare, ecc).
Ciao Andrea.
Alcune mie considerazioni sul riscaldamento a pavimento.
a) Non è vero che si ha un notevole risparmio energetico rispetto a quello tradizionale con radiatori, (verifica effettuata su due appartamenti di eguale superficie e caratteristiche).
b) Nei bagni, data la loro esegua superficie pavimentata, non è opportuno installare serpentine riscaldanti, che risulterebbero di norma, di lunghezza insufficiente.
c) Se la temperatura della pavimentazione superasse i 29° C, creerebbe alle persone anziane o con problemi cardiocircolatori e asmatici dei seri problemi, (ASL Regione Veneto).
d) Elevato costo di installazione.
e) All’avvio di un impianto, dopo un periodo di inattivazione oppure al primo utilizzo, sono necessari da 12 a 24 ore per raggiungere la temperatura ambientale a regime.
In conclusione secondo la mia opinione, non vedo quei strepitosi vantaggi sul riscaldamento a pavimento rispetto a quello tradizionale.
Spero a breve di potervi dare delle notizie circa un impianto radiante completamente annegato in un massetto in argilla sul quale verrà steso un pavimento monolitico in argilla.
Credo di poter asserire senza tema di smentite che questo massetto in argilla grazie alla sua inerzia termica, sarà un vero e proprio toccasana, fonte di ulteriore riduzione di apporto energetico, con l’aggiunta che in estate sarà un blocco raffrescante naturale.
Cordialità.
Bioedilapulia di Paolo Iusco
Come io vedo il pavimento radiante:
– valvole di zona da vietare, salto termico 7-10 °C quindi temperatura di mandata almeno 35/38 °C con lavoro discontinuo da vietare
– arredamento in zona perimetrale quasi ininfluente perchè, anche se impedisce lo scambio termico con la parte areica soprastante, irradia costantemente un corpo che aumenta la massa termica interna
Ciò che io tocco con mano quotidianamente (il mio impianto): pompa di calore con temperatura di mandata 25 °C costanti con casa a T costante che mai scende sotto i 19.5 °C e mai supera i 21 °C con temperatura esterna variabile tra 1 e 4 °C. Quel minimo di sovratemperatura mi aiuta nei ricambi d’aria e per le pulizie.
I sistemi di controllo, le valvole di zona, le testine termostatiche, i cronotermostati ambiente lasciamo che vengano utilizzati solo per la differenziata con il recupero dei materiali nobili di cui sono composti.
Cordiali saluti
La temperatura massima superficiale è stabilita dalla norma UNI 1264 e vale in tutta Italia non solo in regione Veneto. A questa si deve fare riferimento.
Certo che non si ha un risparmio energetico con impianto A piuttosto che B: non è l’impianto che consuma ma è la casa, sempre! Il pavimento radiante offre solo un comfort maggiore.
L’unico vantaggio dei sistemi ad alta temperatura con funzionamento discontinuo è che nel caso si debba “tirare la cinghia” si possono mettere in funzione solo in caso di freddo davvero insopportabile o solo la sera per la cena o stando a guardare la TV.
Il resto sono chiacchiere di venditori arraffoni e ignoranti: un edificio ha bisogno di X Kcal e comunque vengano fornite sempre quelle saranno.
Molto importante: il funzionamento discontinuo ha il grande svantaggio del raffreddamento delle pareti che crea una situazione di scarso comfort, dove anche con temperatura rilevata al termometro di 22 °C si sta sul divano con le varie coperte sulle gambe e felpe spropositate.
Saluti
Personalmente ritengo che il riscaldamento a parete radiante sia da preferire a quello a pavimento: in questo modo diventerebbe utilizzabile anche da tutte quelle persone che, a causa di problemi di circolazione alle gambe, non dovrebbero tenere i piedi a contatto con un pavimento caldo.
@ Enrico
Sto seguendo questa discussione per mio interesse professionale.
In attesa di qualche critica al mio precedente inserimento, vorrei rispondere a Enrico, punto per punto.
a) il risparmio lo si vede solo se si mette a confronto due identiche abitazioni con il riscaldamento in continuo. In tutti gli altri casi il termosifone ha i suoi vantaggi soggettivi. Nel link inserito vengono considerati i termosifoni in alluminio perché hanno bassa inerzia, quindi riscaldano subito. Se si utilizzassero quelli in acciaio (o peggio quelli in ghisa) si vedrebbe nettamente il vantaggio di un riscaldamento a pavimento (per minima presenza di moti convettivi, con movimento di polveri e acari, per calore uniforme; una volta impostata la temperatura, non si osservano sbalzi durante la giornata, a meno che ci siano giornate con cambiamenti repentini esterni).
b) È per quello che viene montato uno scalda-salviette in aggiunta all’impianto esistente. In più bisogna fare i conti con la superficie del bagno: più è piccola e più conviene uno scalda-salviette (o termosifone, ma quale? in base a quello che si sceglie bisogna cambiare la caldaia perché se metto uno in ghisa, per esempio, la caldaia deve essere per alte temperature, quindi non a condensazione, in contrasto con il riscaldamento a pavimento).
c) È giusto! Secondo la norma UNI EN 1264 si ha comfort se non si superano i 29°. Ma perché si deve superare i 29°? Forse perché chi ha un impianto a pavimento lo vuole usare con le fasce orarie, come con i termosifoni; e hanno l’esigenza di scaldare al più presto, non capendo che stanno consumando un baito.
d) Non esageriamo. Quando si parla di soldi bisogna guardare con una prospettiva più ampia del semplice costo di installazione; bisogna guardare anche il risparmio di carburante negli anni, il miglior comfort abitativo, la diminuzione di allergie, la minore manutenzione dell’abitazione (i termosifoni creano le classiche “fiammate” nelle pareti o, sicuramente, sulle tende, che dovranno essere lavate almeno una volta all’anno).
e) Considerando quanto detto sopra, non bisogna usare l’impianto a pavimento come uno a termosifoni. Se oggi, per esempio, è arrivato un freddo improvviso, difficilmente possiamo utilizzare il riscaldamento a pavimento in modo da riscaldare a sufficienza. Ma domani avrò la temperatura adatta. Forse non servirà, perché è ritornato il caldo, ma queste situazioni si risolvono con un maglione più grosso; mentre con i termosifoni si consumerà molta energia perché dovranno riscaldare tutto l’ambiente (attualmente ci saranno muri, pavimenti, mobili freddi) per avere un percezione di ambiente confortevole.
Scusate la lungaggine, ma ritengo che per fare delle obiezioni o valutazioni si debba considerare molti fattori, che hanno bisogno di essere espressi per giustificare il giudizio finale (personale).
In risposta al quesito di Luca (assolutamente da non criticare).
– l’impianto a soffitto al piano terra potrebbe essere una scelta da considerare in quanto il gradiente termico (°C/ml) tra soffitto e pavimento (considerando che l’altezza operativa di interpiano è 2.8 ml) non è esagerato. Basti pensare infatti che il gradiente è di circa 1 °C / ml. Per esempio se la temperatura del soffitto fosse 22 °C ad altezza uomo avresti circa 21 °C, tollerabili quindi senza difficoltà. Al pavimento avresti circa 19°C.
Comprendo il tuo scetticismo sul radiante a pavimento anche se per esperienza non ho mai avuto problematiche di sorta sul soddisfacimento del fabbisogno termico. L’importante è scegliere un’adeguata termoregolazione.
– vero che in genere la resistenza termica del rivestimento in legno è superiore al ceramizzato, ma è anche altrettanto vero che un incremento di temperatura di mandata di 5-7 °C non genera consumi specifici così elevati da inficiare l’aspetto decisionale.
Concordo pienamente che l’isolamento dell’involucro edilizio deve essere il più possibile adeguato alle prestazioni che si vogliono raggiungere (e questo indipendentemente dal tipo di impianto).
Un pessimo isolamento delle superfici scambianti con l’esterno genera delle perdite di energia che purtroppo si pagano per tutta la vita utile dell’immobile.
Riscaldare una casa con i pannelli solari, se sul piano teorico potrebbe anche essere tecnicamente fattibile, diventerebbe insostenibile dal punto di vista economico. Il solare termico potrebbe certamente sostituire la caldaia durante il periodo estivo quando l’efficienza dell’impianto segue la sua curva di massima prestazione, d’inverno credo non sia possibile per svariate motivazioni.
Leggendo altri forum ho trovato questa immagine: http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/distribuzione_temperatura.jpg
Purtroppo non conosco la fonte, ma mi sta a cuore il confronto tra i tre tipi di radianti.
A pavimento (2° figura). È molto simile alla curva ideale (1° figura): c’è una zona di h=50 cm che ha una temperatura dai 20.5°-24°. Poi rimane costante fino ai 2.75 m (20.5°); infine si abbassa ai 19°. Sarebbe più che ottimo.
A soffitto (5° figura). I 20° li ottengo solo a 2.40 m. A 1.5 m ci sono 19°. A terra ce ne sono 18°. Ai 3 m si arriva ai 23°. Direi malaccio.
A parete (6° figura). Sembra la più performante vista la costanza di temperatura che va dai 30 cm ai 2.8 m.
Non so che dire. Probabilmente hanno tenuto fisso la temp. d’esercizio, comune in tutti i casi, quando mi sarebbe piaciuto vedere quanta energia serve per ottenere i 20°.
Parlo così perché ho letto che quello a soffitto lavora per irraggiamento, mentre quello a pavimento lavora principalmente per convezione e, poi, per irraggiamento. Ma dichiara che riscaldare gli oggetti è meglio che riscaldare l’aria, perché basta un ricambio d’aria e ho un disagio, mentre con gli oggetti caldi (come anche il pavimento) si mantiene il comfort abitativo.
Per Luca.
Hai fatto tre interventi un po’ confusi, probabilmente se ascolti e leggi quello che ti propinano le varie opportunità presenti sul mercato è ovvio che l’aspetto commerciale prevale su quello tecnico, pertanto suggerisco sempre di usare la testa e le cognizioni di base che dovrebbero essere chiare a tutti.
1°) Il consumo, a parità di condizioni climatiche interne, è determinato esclusivamente dall’involucro dell’edificio e in secondo dall’efficienza dell’impianto (caldaia, distribuzione ecc.).
2°) Il calore, ad esclusione che nel vuoto, si trasmette sempre secondo i tre sistemi conosciuti: radiazione, convezione, conduzione. Tra i vari sistemi di distribuzione del calore varia solo la loro proporzione.
3°) Il corpo umano ha un metabolismo che emette circa 100 W in condizioni di moderata attività e ha una temperatura di circa 37 °C. Buona parte di questa energia viene emessa tramite la respirazione e il vapore acqueo contenuto e anche per irraggiamento. Per tale motivo, in assenza di vento, è molto più sensibile al calore irradiato dall’ambiente che a quello dell’aria che lo circonda (da ricerche fisico/mediche il 70 % del calore viene ricevuto per irraggiamento); questo porta ad ottenere lo stesso comfort fisiologico ad una temperatura ambientale inferiore se il corpo è circondato da strutture con temperature uniformi e relativamente calde.
In pratica, “semplificando”, lo stesso comfort si può ottenere tanto con un impianto radiante che convettivo a condizione che tutta la struttura raggiunga la stessa temperatura; cosa più facile da ottenere con un impianto radiante sempre in funzione alla temperatura ambiente di 18-19 °C rispetto ad uno convettivo azionato on/off dal solito (maledetto) cronotermostato con 20-22 °C di temperatura dell’aria ma con pareti/pavimenti/soffitti a 15 °C. Questo minore gradiente termico porta anche ad una riduzione dei consumi pari a circa un 7 % per ogni grado di temperatura inferiore.
4°) L’impianto radiante a pavimento può essere paragonabile ad un radiatore di grande superficie. Il contenuto d’acqua è inferiore a 1 l/mq quindi molto simile a quello di un radiatore, l’inerzia termica del sistema è determinata dal peso del massetto o della struttura che lo avvolge. Nel caso dei classici 4,5 cm + 1 di rivestimento corrispondenti a circa 110 kg/mq. Questo vuol dire che per aumentare di 1 °C la temperatura del mio radiatore devo fornire circa 25 kCal/mq (calore specifico x massa).
In un locale di 20 mq, per portare il pavimento da 15 °C a 23 °C, dovrò “spendere” 4.000 kCal. Tante ma considera che l’operazione è “una tantum” poichè l’impianto a pavimento funziona sempre a regime e che il calore speso viene comunque trasmesso all’ambiente in fase di spegnimento o di riduzione della richiesta termica dell’ambiente e quindi non viene perso nulla. (Mediamente l’incremento della temperatura della superficie del pavimento è di circa 1,5-2 °C/h; quindi non servono 15 ore come qualcuno ha scritto).
5°) La diatriba sulla nocività e altre amenità “per sentito dire”. 29 °C di temperatura superficiale del pavimento è una norma che stabilisce questo come massimo valore, ma in vita mia ho visto solo impianti mal regolati/dimensionati/condotti per giustificare quella temperatura. Se controlli la temperatura di qualsiasi impianto radiante difficilmente troverai valori superiori a 22-23°C salvo trovarsi in strutture “disastrate” con dispersioni fuori controllo.
Considera che l’emissione di calore di una superficie radiante è di circa 10-12 W/mqK; quindi in un ambiente a 19 °C, con pavimento a 22 °C, si ottiene un’emissione termica di circa 35 W/mq, mediamente sufficiente per una struttura decentemente coibentata. Ovvio saranno richiesti valori maggiori in occasione dei picchi negativi di temperatura esterna, ma in ogni caso, anche per il più estremo, difficilmente la temperatura superficiale supererà i 25-27 °C.
Questa modesta variazione del gradiente ha pure un altro vantaggio: quello di rendere il sistema “autoregolante” in quanto l’aumento della temperatura ambiente, dovuta spesso a concause esterne, comporta di pari una notevole diminuzione dell’emissione di calore anche se questo non vuol dire che non serve un sistema di regolazione appropriato; anzi questo, spesso trascurato, è fondamentale.
6°) A prescindere dai costi, anche se non si dovrebbe, si possono ridurre le inerzie del sistema con la riduzione della massa da riscaldare: massetti di ridotto spessore o a secco, impianti a parete o soffitto radiante sulle cui altre differenze si è comunque già scritto.
7°) La finitura del rivestimento del pavimento è importante in quanto come abbiamo visto è la temperatura della superficie che emette calore, quindi se frappongo dell’isolante, tra questa ed il massetto, penalizzo l’efficienza dell’impianto. Per questo l’impiego di rivestimenti in legno o altri materiali sintetici con bassa trasmissione del calore non deve in ogni caso superare il valore di 0,1 mqK/W, oltre che considerare una maggiore quantità di tubazione per mq di pavimento (passi di posa più stretti) e/o una maggiore temperatura media dell’acqua dell’impianto.
8°) Un bagno di 6 mq richiede circa 600 W di potenza termica per riscaldarlo a 20-22 °C nelle peggiori condizioni di progetto; questo corrisponde a 100 W/mq. Questo valore di emissione si ottiene tranquillamente con un passo di posa dei tubi compreso tra i 5 e i 10 cm e con una temperatura media dell’acqua tra i 35 e i 40 °C che nella peggiore delle ipotesi corrisponde a una temperatura di ritorno in caldaia (dT=10 °K) di soli 35 °C, garantendo un funzionamento in condensazione anche alla peggior caldaia istallata o una mandata di 42-43 °C per una pompa di calore (dT=5 °K).
Attenzione, questi sono i valori limite di progetto, quelli medi stagionali sono notevolmente ancor più favorevoli a un ulteriore risparmio rispetto altri sistemi (il dT = 10 °K è consigliabile con le caldaie a condensazione, dT inferiori innalzano la temperatura di ritorno dell’acqua in caldaia penalizzando il rendimento e richiedendo maggiori consumi elettrici alla pompa di circolazione).
9°) Il raffrescamento. Non ho grande esperienza in merito, ma sempre usando la testa e i diagramma di Mollier dell’aria umida, posso verificare le condizioni limite per le quali si formerebbe condensa sulla superficie del pavimento:
– considerando una temperatura ambiente di 27 °C (bulbo secco)
– con umidità relativa del 70% (temperatura di bulbo umido 23 °C)
otterrei la formazione di condensa se la superficie fredda scendesse al di sotto di 15-16 °C.
Ora, a prescindere che un pavimento a 15 °C può dare molto fastidio dal punto di vista fisiologico, vorrei fare osservare che in queste condizioni sarebbe in grado di assorbire ben oltre 100 W/mq; ora mi domando quando mai?
Certo è comunque che per parlare di impianto di condizionamento occorre che si tratti anche la correzione dell’umidità relativa. Ma anche qui, senza andare a cercare costose soluzioni (e dai con i cattivi consigli) di deumidificatori a pompa di calore, basta integrare nel sistema uno o più semplici ed economici ventilconvettori che se alimentati con acqua refrigerata e comandati da un umidostato ambiente, possono benissimo deumidificare l’ambiente e quelli attigui.
10°) Come tutti gli impianti, anche e sopratutto quello a pavimento ha bisogno di una regolazione a cominciare da quella fondamentale di bilanciare i vari circuiti di cui è composto. L’alternativa, che è una cattiva abitudine di idraulici e pure termotecnici, è quella di usare sistemi di regolazione a punto fisso accompagnati da regolazioni on/off sul collettore per ciascun anello dell’impianto.
Questo, oltre a un maggior costo, comporta uno spreco energetico a carico di caldaia o pompa di calore, costretti in condizioni più penalizzate in termini di rendimento.
11°) Sempre per motivi di marketing che poco hanno a che vedere con gli aspetti tecnici, si trova ancora diffusa l’opinione che la sezione del tubo è fondamentale per avere una maggiore resa dell’impianto (resa intesa come minor temperatura media necessaria dell’acqua). Questo è vero, ma si tratta di miglioramenti di una o due unità percentuali che riportati sulla scala delle temperature in °C corrispondono a decimi di °C.
Invece ottengo altri sprechi quali: maggior costo, maggior contenuto d’acqua, minori dT, minori perdite di carico che ne rendono problematico il bilanciamento, minori velocità dell’acqua nelle tubazioni che provocano depositi di limo ed altro. Quindi ricordarsi che la sezione del tubo, come per gli altri tubi dell’impianto, deve essere dimensionata in funzione della portata e della lunghezza e non di default.
Tanto per dare un riferimento, la tendenza è quella di standardizzare a circa 100 m come lunghezza massima di ogni anello che con un passo di posa di 15 cm è in grado di coprire circa 15 mq; una richiesta di emissione di calore di 60 W/mq fanno 900 W che con dT = 10 °K richiede una portata di 77 l/h. Questa portata, con un tubo da 17×2, comporta una velocità dell’acqua di soli 0,16 m/s e una perdita di carico dell’intero anello di 40 mbar (0,4 m), anche con una p.d.c. e dT = 5 °K; ciò comporta il raddoppio della portata e della velocità dell’acqua, i valori restano sempre molto contenuti e la perdita di carico sale ad appena 140 mbar (1,4 m.c.a.), ampiamente entro i limiti di qualsiasi progetto tanto che sarebbe sufficiente con dt = 10 °K anche l’utilizzo di una tubazione da 14×2 come fanno ormai da anni dove si ragiona con carta e penna e non sui depliant.
12°) Altra diatriba sul tipo di pannello isolante. E’ meglio quello liscio con tubo graffettato? Quello su liscio e tubo “clippato” a una rete metallica? Quello su panello bugnato?
Diciamo subito che dal punto di vista tecnico o meglio in termini di resa (uguale emissione a temperatura media dell’acqua inferiore) le differenze tra una filosofia e l’altra sono minime, anche qui nella peggiore delle ipotesi corrispondenti a 1-2 °C in più della temperatura media dell’acqua. A questo punto analizziamo l’aspetto economico. Premettiamo che tubo e resto dell’impianto non variano ma:
– l’impianto su pannello liscio + le graffette + il tempo di posa alla fine non offre vantaggi in termini di tempo di posa o di costi, anzi si presta ad errori di posa e alla capacità e all’inventiva del posatore.
– l’impianto su pannello liscio + rete + clips + tempo è senz’altro superiore per costi di materiale che di manodopera. La rete è vero da maggior solidità al massetto ma è falso che ne impedisca la fessurazione; ricordo che il massetto non ha funzioni statiche, salvo che in impianti industriali o gravati da carichi particolari nel cui caso occorre una progettazione apposita e che necessita di ulteriori e in ben maggior quantità di ferri.
Vorrei chiedere a questo punto tra i lettori quanti siano mai andati a visitare fiere oltre confine (ISH tanto per citarne una) e avessero fatto caso a quanti produttori fuori dal nostro paese abbiano ancora a listino sistemi diversi da quello bugnato? Ritenete sia una questione di costi o di tecnologia? Ritenete ancora che quello che vi racconta il venditore della ditta “taldeitali” e che l’impianto di riscaldamento a pavimento per uso civile su rete sia il migliore?
Se ho scritto qualcosa che non vi soddisfa o che non sia conforme al vs. pensiero sarò lieto di confrontarmi con chi ne sa di più, spero solo sia bravo a convincermi con dati alla mano e non con i link commerciali.
Grazie Paolo per le tue precisazioni.
A questo punto, sempre se ti fa piacere mettere a disposizione le tue conoscenze, potresti fare una piccola digressione dal discorso sul radiante a pavimento e metterlo a confronto col radiante a soffitto?
Precisazioni per Luca, Paolo (e altri)
1) Il consumo di un impianto non è determinato solo dall’involucro edilizio e dall’efficienza del medesimo quanto bensì anche dalle condizioni di temperatura esterna di riferimento (temperatura di progetto) della località ove è situato l’immobile. Un impianto di riscaldamento deve tener conto in fase progettuale dei seguenti parametri:
– temperatura esterna di progetto Te;
– n. di gradi giorno GG;
– n. dei giorni di riscaldamento (zona climatica)
La norma UNI 10349 (dati climatici località italiane) li specifica chiaramente. Il n. di gradi giorno da soddisfare alle varie latitudini è una condizione necessaria e sufficiente per stabilire il consumo di un impianto anche se su base analitica.
Vero è tanto che la potenza termica a cui deve soddisfare l’impianto di produzione su base oraria deve tenere in considerazione i seguenti contributi:
– contributo alla potenza dispersa per trasmissione;
– contributo alla potenza dispersa per ventilazione;
– contributo alla potenza dispersa dei ponti termici lineari.
Si confronti in merito il DLgs. 192/05 e s.m.i. DLgs. 311/06 oltre a DPR 412/93 e DPR 551/99. I fabbisogni termici non vanno considerati ad “capocchiam o a mq/mc di superficie ma seguendo la UNI TS 11300-2.
3) Il corpo umano e quindi lo scambio di energia in ambiente (oltre a quello nel cavo polmonare) non è costante nella misura di 100 W/mq, ma è funzione di alcune variabili intrinseche come:
– temperatura omeotermica del corpo umano (variabile tra 35.9 – 37.2°C;
ed alcune variabili estrinseche come;
– peso dell’individuo
– indice di massa corporea;
– superficie epidermica globale.
Per ottenere lo scambio termico si usano svariate equazioni generalmente non su base lineare come ad esempio la legge di Dubois.
A titolo di esempio (e sulla base di un conteggio fatto su di me), un individuo del peso di 75 kg e avente un’altezza di 180 cm, ha una superficie epidermica globale di quasi 2 mq. Lo scambio di energia per effetto di tipo convettivo ed evaporativo (ah dimenticavo in fisica tecnica i meccanismi di scambio termico sono 3, in energetica degli edifici ove si studiano gli equilibri edificio-impianto, uomo-impianto sono 4 c’e’ lo scambio termico di tipo evaporativo) è di 58 Wh/mq. In sintesi per l’uomo in questione si emette in ambiente una quantità di calore pari a 116 Wh.
Inoltre la temperatura di riferimento interna degli ambienti sulla quale si definisce la condizione di comfort (cfr ISO 7730) è quella operativa e non delle superfici ambientali soltanto (è la temperatura uniforme che si ha all’interno di una cavità radiante in cui un occupante scambierebbe la stessa quantità di energia termica radiante e convettiva scambiata nelle effettive condizioni di ambiente non uniforme).
Dire che il comfort a parità di temperatura ambiente si raggiunge sia con sistemi convettivi che irradiativi non è corretto. Legato al comfort il concetto è esprimibile attraverso l’analisi di Fanger relativamente al voto medio previsto (PMD) e rilevato (PPD) di un campione di persone all’interno di un ambiente.
Secondo Fanger, se almeno il 10% della curva caratteristica della grandezza da soddisfare è costituita da persone insoddisfatte, allora il comfort può essere raggiunto. Andando oltre Fanger, per i sistemi convettivi (corpi scaldanti ad aria) l’elemento di disturbo sovente è rappresentato dalla velocità dell’aria e quindi dai moti convettivi generati, a parità di temperatura operante (es. 20°C). Ritengo quindi che i sistemi radianti siano da preferire rispetto ai convettivi.
Questi elementi sono invarianti rispetto al sistema di termoregolazione ambiente usato.
4) L’impianto a pavimento non ha un contenuto d’acqua costante, ma dipende dal passo di posa della distribuzione. Nelle superfici marginali ove la norma UNI EN 1264-1-2-3-4 prevede un limite della temperatura superficiale del rivestimento di 35 °C per sopperire alle aree nelle quali i ponti lineari creano carenza termica, il passo della distribuzione certamente è diverso da quello delle superfici soggiornali (in genere si raddoppia) e quindi anche il contenuto d’acqua si raddoppia.
Ad esempio usando un tubo da 17 mm x 1 per ogni ml lineare il contenuto d’acqua è pari a 0.1769 lt. Con un passo di posa pari a 15 cm, l’incidenza è di 6.66 ml/mq con un contenuto d’acqua di 1.178 lt. Lungo le superfici marginali, raddoppiando il passo a 7.5 cm, l’incidenza è di 13.33 ml/mq il cui contenuto d’acqua è di 2.356 lt/mq. Il contenuto d’acqua di un radiatore la cui superficie di emissione sia 1 mq dubito possa raggiungere il lt.
In genere il contenuto, così come la potenza emessa, sono parzializzati ad ogni singolo elemento e variano in base all’altezza ed alla sua configurazione (doppia o singola). Inoltre è da distinguere tra radiatori in acciaio (a maggior contenuto d’acqua) e radiatori in alluminio (a minor contenuto d’acqua).
L’inerzia, come detto, dipende dalla stratigrafia dell’impianto radiante, anche se in genere le prestazioni possono essere migliorate non usando cls tradizionali, ma cls con granulometria in curva di Fuller ed eventuali additivi in grado di incrementare sensibilmente (attenzione ripeto sensibilmente – cfr UNI 8102) le caratteristiche termiche di un prodotto a base cementizia con legante idraulico non a caratteristiche std invero 32.5 N/mmq, meglio un 42.5 N/mmq (cfr UNI 107). Es. BetonFloor. Da non dimenticare infatti che il massetto a matrice cementizia deve anche sopportare i carichi propri e permanenti. Vero è tanto che per impianti radianti in basso spessore (2 cm sopra la generatrice superiore della distribuzione) vengono (se esiste il progettista che conosce la materia) impiegati cls di classe 52.5 N/mmq secondo ENV 107.
L’inerzia, al primo avvio è certamente notevole, ma quando l’impianto è entrato a regime, invero la massa termica si è attivata nella cessione di calore, anche eventuali riduzioni notturne (non è consigliata l’intermittenza) vengono superate con estrema “velocità” rapportate al tipo di impianto (4-6 ore per risalire al mattino di 1-2°C). Il fabbisogno di un locale (di superficie qualsivolglia e quindi 20 mq) non è detto che sia di 4000 kcal/h (ah le unità di misura del tipo menzionato non si usano più perchè facenti parte del ST oggi si usano le unità del sistema SI W/h) perchè altrimenti vorrebbe dire avere già fatto delle ipotesi come condizioni al contorno. E’ preferibile non dare i numeri come alla ruota della fortuna.
Il fabbisogno specifico a mq o a mq deve tenere in considerazione fattori legati alla stratigrafia delle superfici scambianti con l’esterno, alle caratteristiche di trasmittanza termica dei materiali (U) e alle caratteristiche dei componenti finestrati. Dire che un locale di 20 mq abbisogna di 4652 Wh (4000 kcal/h) è improprio, meglio non dirlo.
5) Le temperature massime superficiali contemplate dalla norma UNI 1264 (29 °C per superfici soggiornali, 33 °C per servizi igienici, 35 °C per superfici marginali) NON sono le temperature di progetto. Se l’impianto viene realizzato su abitazioni poco dispersive dal punto di vista energetico, la temperatura pavimentale è notevolmente inferiore, al contrario ovviamente per le abitazioni “energivore”.
Pratica comune soprattutto da parte dell’installatore che ha posato male l’impianto senza progetto (perchè secondo lui costa) è quella di alzare la curva climatica dell’impianto per sopperire le negligenze di installazione o sottodimensionamento degli anelli.
L’emissione termica in ambiente, invero “l’emissione areica” segue una legge non lineare del tipo: (cfr UNI EN 1364)
Q = 8,92 (Tpav – Ta) ^ 1,1
m = coefficente esponenziale per il tipo di impianto che per i sistemi radianti vale 1.1.
Applicando l’equazione considerando una Tpav = 29 °C, una Ta = 20 °C si dovrebbero ottenere i 100 W/mq menzionati.
8) Vedi il punto 1) il fabbisogno di un locale non si può standardizzare. Secondo la norma per il raggiungimento della temperatura operante nei servizi igienici con Ta = 22 °C si potrebbe arrivare anche a 135 W/mq, 150 W/mq lungo le superfici marginali.
9) Nel raffrescamento a pavimento l’impianto inverte il suo ciclo funzionale, asporta calore anzichè cederlo in ambiente. In questi impianti le grandezze da controllare sono 2:
– temperatura operante 26-28 °C (cfr ISO 7730) o al massimo delta T esterno/interno = 6 °C;
– umidità relativa.
L’impianto radiante può lavorare discretamente sulla componente sensibile dei carichi termici estivi, ma poco o nulla sui carichi latenti. L’abbinamento a un sistema di controllo dell’umidità risulta necessario (eccetto ad alcune latitudini ove l’umidità estiva si mantiene su valori del 40-50 %).
Il problema fondamentale sul carico latente è il raggiungimento della temperatura di rugiada dell’aria umida che varia in base alle condizioni di temperatura esterna.
L’uso di diagrammi psicrometrici consente di definire qual è la temperatura minima di soglia oltre la quale si verifica il fenomeno della condensa, ovviamente sempre da evitare. L’impiego di microcontrollori in grado di gestire anche una curva climatica estiva ben rispondono a tali esigenze. Pilotare unità ad aria con comandi dà un buon contributo al controllo dell’umidità relativa in ambiente.
In tali impianti si definisce a monte quindi anche l’intervallo della temperatura di mandata all’impianto (17-22 °C). Ottimo sarebbe anche la regolazione della temperatura di mandata con valvole miscelatrici gestite da segnali 0-10 V 4-20 mA (se fosse anche a 230 V non ci disperiamo). Esperienze positive le ho avute con microcontrollori della serie Large della Siemens (RVS 43- RVS 63 ed ante RVP 80) con sonde a 5 fili termoigrometriche. Altre regolazioni lavorano bene (es Carel), ma sono estremamente complicate nella programmazione del PLC (le programmavo eh eh). L’importante è impiegare dispositivi in grado di avere prestazioni sul carico latente che usino il medesimo intervallo di temperatura di alimentazione del radiante, diversamente si corre il rischio per risparmiare qualcosa sul terminale ad aria di vanificare l’effetto del contributo sul carico sensibile dell’impianto dovendo abbassare notevolmente il setpoint di temperatura del refrigeratore condensato ad acqua (7-12 °C). I gruppi frigo con doppio setpoint hanno proprio questa funzione :-(
Difficilmente si ottengono assorbimenti descritti dell’ordine dei 100 W/mq come indicato, quando va bene, ma veramente bene (e questo dopo il campionamento con una serie di datalogger su un ambiente raffrescato senza apporti gratuiti particolari si arriva a 40-50 W).
Altri tipi di impianti come il radiante a soffitto o il parete hanno in genere sul freddo prestazioni migliori (minore inerzia termica a causa di altri materiali in gioco)
10) La termoregolazione è importante. La migliore sul circuito è la valvola miscelatrice (pivotante/modulante 0-10 V 4-20 mA o 230 V dipende) con sonda ambiente dotata di influenza e se a 4 punti meglio. Ciò che invece si vede in giro è di tutto, termostati a 2 punti sulla pompa, sulla valvola, sulle teste elettriche (regolarmente aperte e senza collegamento perchè l’elettricista non le collega quasi mai giuste !!!), punti fissi e quanto altro ci sia di peggio. Quello che è meglio tecnicamente non sempre lo è per l’idraulico (come se fosse lui a pagare e a decidere cosa è meglio per la casa di ciascun utente).
11) Sulla sezione del tubo (circolare o ovale) poca differenza esiste come menzionato. L’impiego di tubazioni a sezione ovale (se ci sono ancora) può avere senso negli impianti a basso spessore o dove ci sono particolari problematiche di realizzazione dell’impianto sempre però legate al suo spessore.
L’esempio numerico descritto può avere senso ai fini della velocità dell’acqua dentro il tubo e della velocità quindi di messa a regime dell’impianto, ma fissare le condizioni al contorno sulla lunghezza massima degli anelli ha anche un altro significato, invero di progettare l’impianto con il metodo delle perdite di carico costanti affinchè per poter rispettare l’NPSH definito dalla pompa selezionata, non si debbano scegliere pompe con Q-Hp sproporzionate rispetto alle portate/prevalenze necessarie e quindi costose.
Nei sistemi a spessore standard di impianto si usano tubazioni da 17×1, 17×2 (dipende se PB-PE-PEX-a,PEX-b,PEX-c), nei sistemi a basso spessore 12×1, 14×1, 14×2 mm, nei sistemi a parete 10×1 e nei sistemi a soffitto 8×0.8, 8×1.I diametri dipendono anche dal costruttore del tubo :-). I francesi usano il reticolato elettrofisico di tipo anodico da 17×1 e 17×2 a crescere, i tedeschi il reticolato dow corning ed elettrofisico da 16×1, 16×2 etc etc.
12) Relativamente alle differenze tra i sistemi su pannello liscio o su pannello bugnato, in linea di principio a rigor di tecnica, essendo nel pannello bugnato venir meno il contatto tra tubo e bugna in numerosi punti del pannello, c’e’ minor superficie di scambio e quindi minor resa (trattasi di poca cosa dalla letteratura e da esperimenti eseguiti quando stavo in RDZ; se si arriva al 2% è tanto).
Da dire inoltre che in sezione trasversale la cessione di calore sul pannello liscio è più uniforme giacchè la sezione è più uniforme (trattasi sempre di valori bassissimi) e sulla superficie del rivestimento l’effetto ondulatorio della temperatura è quasi inesistente (simulazione termica con codice FEM – Straus 7.0).
A produrlo il pannello liscio costa meno (stampo più semplice) rispetto al bugnato (stampo più complesso).
Da quasi 2 decenni frequento Utrecht, MCE, ISH, Interclima e altre manifestazioni del settore e chi propone pannelli lisci su rete o bugnati con clips lo fa per differenziarsi dal punto di vista del marketing e non per la resa o l’efficienza dell’impianto. Tra l’altro sembra che da qualche anno ormai i produttori vogliano certificare il sistema conformemente alla UNI 1264 non accontentandosi della certificazione di prodotto, come se l’impianto funzionasse meglio ah ah ah. Insomma ognuno cerca di portar l’acqua al proprio mulino.
Grazie Paolo.
Prendo per oro colato tutto il tuo discorso, così da correggere le mie conoscenze.
Ti chiedo per favore, di chiarirmi il discorso della sezione dei tubi: stavo pensando ad un riscaldamento a soffitto capillare, dove i tubi hanno una sezione di 4.3 x 0.8 mm (non so cosa voglia dire 4.3) con passo di 20 mm annegati nel primo cm dell’intonaco.
Secondo il tuo ragionamento, l’energia termica emessa dal sistema sarà principalmente mediante irraggiamento, dato che non esiste piastra da riscaldare prima di diventare radiante.
Inoltre, mi sembra di aver capito che più è piccola la sezione del tubo e meno acqua consumo, più velocità dell’acqua (con pressione max 6 bar), meno inerzia termica, ecc.
Vado bene con il ragionamento?
Mi piacerebbe saperne di più anche delle soluzione dei ventilconvettori.
Intanto faccio un paio di calcoli considerando i valori che mi ha scritto.
Grazie ancora.
Ammazza!!! Mi assento un attimo e trovo Gennaro!!!
Me lo leggo attentamente e, comunque, chiedo a Gennaro le stesse cose per quanto riguarda il riscaldamento a soffitto e una soluzione per evitare condense e muffe (anche se ho letto velocemente che parlavi di microcontrollori).
Mi scuso per aver invaso uno spazio probabilmente riservato ad altri.
Mi sono permesso di buttar giù una dozzina di punti per chiarire quali sono le caratteristiche di un impianto radiante in modo semplice e comprensibile da chi aveva postato opinioni che mi sono sembrate errate che ritengo siano dovute a luoghi comuni ancora molto diffusi. Ho quindi dato per scontato dei default evitando citazioni e riferimenti a normative ma solo basando quanto ho scritto su valori generalmente accettati senza alcuna pretesa che siano adatti a tutte le condizioni ma che siano solo dei valori di riferimento.
Lungi da me l’intenzione di aprire flame, condivido tutti (quasi) gli appunti riportati in modo molto ingegneristico, ma puntualizzo:
“1) Il consumo di un impianto non è determinato solo ….”
Ha perfettamente ragione dovevo aggiungere a parità di condizioni climatiche esterne (mai dare per scontato).
“3) Il corpo umano ….”
Idem come sopra.
“Inoltre la temperatura di riferimento interna degli ambienti”
Eccellente e precisissima disquisizione, ma una persona la misura con un normale termometro (molti manco hanno quello).
“4) L’impianto a pavimento non ha un contenuto d’acqua costante,..”
Come per i 100 W ho dato il valore di 1 l/mq; l’equiparazione con il contenuto di un radiatore è riferita su un locale di 20 mq (20 l.); un radiatore dimensionato per riscaldare lo stesso ambiente non si dovrebbe discostare troppo da quelle capacità.
“L’inerzia,….. le prestazioni possono essere migliorate ….. ma cls con granulometria in curva di Fuller”
La mia esperienza in cantiere con imprese edili, muratori, posatori di massetti sia “sabbia e cemento” che quelli (sembra) più specializzati per i preparati liquidi autolivellanti è disastrosa sul pressapochismo e direi ignoranza sull’argomento. Più volte trovo realizzati massetti cui non è stato aggiunto l’additivo nella quantità prescritta quand’anche nemmeno un po’ e a volte non si rispetta la quantità minima di cemento in rapporto alla sabbia secondo le specifiche indicate. Figuriamoci se questa gente capisce di cosa stiamo parlando.
Poi, a prescindere dall’assunzione di qualsiasi responsabilità per quei lavori malfatti, nonostante ci si ritrovi pure con spessori inferiori a quelli di progetto come pure variazioni anche del 50 % tra punto e punto del massetto, ma che a distanza di anni non hanno dato problemi nè di fessurazioni nè di malfunzionamenti.
Con questo non è che sia una mia approvazione al malvezzo, ma nonostante per quanto si cerchi di fare del proprio meglio, capiti lo stesso qualche inconveniente, ci siano conclamati ed evidenti casi di cattiva esecuzione che nonostante tutto siano lì a funzionare nella soddisfazione del cliente utilizzatore e a dimostrare che forse tante ns. preoccupazioni forse sono fuoriluogo (forse?).
“(ah le unità di misura del tipo menzionato non si usano più ..”
Lo so ma ci sono affezionato e poi le chilocalorie lo sanno tutti che hanno a che fare con il calore; quando parli di watt il 90% della gente pensa alle lampadine. :D Inoltre 1 kg di acqua (lascia perdere i 4°C) per 1 °C (lascia stare da 277,15 K a 278,15 K) fa 1 Kcal è troppo comodo per lasciarlo nel cassetto dei ricordi.
“5) Le temperature massime superficiali ….NON sono le temperature di progetto.”
Non l’ho scritto da nessuna parte che siano temperature di progetto, ma le massime previste dalla norma e comunque in condizioni di disagio psicofisico.
“L’emissione termica in ambiente, invero “l’emissione areica” segue una legge non lineare del tipo: (cfr UNI EN 1364)”
Vero, ma nell’ambito abbastanza ristretto dei valori normalmente in gioco la curva della funzione è quasi una semiretta con un’emissione di circa 10-12 W per 1 °C di differenza.
“8) …. si potrebbe arrivare anche a 135 W/mq, 150 W/mq lungo le superfici marginali.”
Hai pienamente ragione, ma spesso queste fasce perimetrali con serpentine più fitte creano difformità della temperatura che può essere anche fastidiosa e un emissione di 135-150 W/mq comporta un pavimento esageratamente caldo pur se limitato ad alcune superfici.
“9) Nel raffrescamento a pavimento l’impianto inverte il suo ciclo funzionale,..”
Ho premesso la mia scarsa conoscenza, tra l’altro ho “cappellato” a traslare i dati relativi al diagramma dell’aria umida (vado a memoria) con i dati ipotizzati, pertanto la temperatura di rugiada dovrebbe essere ben più alta dei 16 °C indicati.
Senza scomodare specialistiche regolazioni programmabili e costosi servocomandi 0/10 V, Honeywell ha una semplice regolazione dedicata a questi sistemi con compensazione climatica con sensore di umidità e temperatura ambiente, con uscita 3 punti per servocomando + uscita on/off per la deumidificazione, in eventuale mancanza della quale (mi sembra) vada a correggere la temperatura di mandata dell’acqua per evitare la condensazione, ovvio che a quel punto il set point non viene garantito, ma ritengo che il fenomeno della condensa si verifichi raramente e in casi abbastanza estremi.
“11) ….L’esempio numerico descritto può avere senso ai fini della velocità dell’acqua dentro il tubo e della velocità quindi di messa a regime dell’impianto”
Non capisco il nesso tra la velocità dell’acqua all’interno del tubo e la velocità di messa a regime dell’impianto. So per certo che a parità di emissione di calore devo garantire uguale temperatura media dell’acqua (e uguali condizioni ambientali ..default), differenti portate e quindi velocità dell’acqua corrispondono in modo inversamente proporzionale a variazioni del dT. La velocità di messa a regime dipende da altro.
“… scegliere pompe con Q-Hp sproporzionate rispetto alle portate/prevalenze necessarie e quindi costose.”
Nell’ambito civile, ma anche quello industriale, degli impianti a pavimento penso che il dimensionamento della pompa sia una delle cose più semplici da fare. Se non sbaglio l’NPSH riguarda la pressione minima sulla bocca di aspirazione per evitare fenomeni di cavitazione che avrebbero effetti distruttivi sulla girante della pompa stessa. Non mi sembra che nel nostro caso sia un parametro da tenere in particolare considerazione visto anche le modeste prestazioni normalmente richieste.
“12) Relativamente alle differenze tra i sistemi su pannello liscio o su pannello bugnato, i… se si arriva al 2% è tanto”
Grazie della conferma. Avresti qualche link sull’argomento?
“Da quasi 2 decenni frequento Utrecht, MCE, ISH, Interclima”
A Parigi non ci sono mai andato, VSK un paio di volte, ISH almeno quattro ed MCE +/- tutte a partire dal 1975 o giù di li. Quello che intendevo era affermare la mia sorpresa di fronte alla praticamente assenza di sistemi di riscaldamento a pavimento su rete o pannello liscio visti all’ISH. Questo anche nei cataloghi delle stesse ditte che qui in Italia insistono invece sulle presunte qualità di quel tipo d’impianto (penso sai bene a chi mi riferisco).
Ne approfitto per una domanda: cosa ne pensi degli isolanti multi-layer riflettenti per impieghi abbinati a sistemi radianti? L’elevato valore di resistenza termica in relazione allo spessore, secondo te si mantiene nel tempo? La compressione dell’isolante dovuta al peso del massetto e dai vari carichi gravanti porta ad un assottigliamento degli spazi arei tra i layer riflettenti. Come si riperquote sul valore della resistenza termica dichiarata?
Per Luca
Il dato che citi di 4,3 x 0,8, se riferito ad un tubo significa che quel tubo ha un diametro esterno di 4,3 mm e 0,8 mm di spessore. Quindi il diametro interno è di soli 2,7 mm.
Per quel tubo può passare pochissima acqua e posto a passi di 20 mm dev’essere per forza ordinato a più file in parallelo facenti capo a un collettore per ciascun lato m/r. Chi produce/vende quei sistemi ha certamente delle tavole di resa in funzione dei vari sistemi d’impiego. Se posizionato a soffitto dovrà avere qualcosa che lo isoli superiormente per evitare un’eccessiva dispersione di calore verso l’alto.
Ciao Paolo, non devi scusarti, anzi ti ringrazio per i preziosi contributi, come ringrazio tutti gli altri che hanno intervenuto e interverranno.
L’importante è commentare in maniera pacata!
Ciao Paolo. Ti ringrazio per la tua professionalità. Avevo capito che eri “meno professionale” per una questione di praticità; ma avevo capito anche che ne capisci sicuramente più di me. Quindi, ti prego di non fermarti ad intervenire per aver ricevuto una risposta con dei toni un po’ autoritari.
Ne va dell’ignoranza nostra: più ci sono persone che parlano ad hoc e più vengono smentite quelle persone che continuano a dichiarare che il caldo va solo verso l’alto.
Salve a tutti,
intervengo solo per dare il mio contributo in quanto ho progettato, realizzato e gestito decine di impianti radianti e posso dire senza dubbi:
1) gli impianti radianti sono sicuramente la miglior soluzione in termini di comfort e risparmio
2) non ha alcun senso installare valvole on-off sui vari anelli dell’impianto
3) un impianto ben dimensionato viaggia a temperature non superiori a 35 gradi (con -10 esterni)
4) a parità di comfort un impianto a radiatori tradizionali consuma il 10-15% in più
5) l’unica alternativa sensata all’impianto radiante è un impianto a radiatori a bassa temperatura ma i costi di realizzazione sono praticamente equivalenti
6) l’unico modo per regolare un impianto radiante è tramite sonda esterna (climatica) e a mio avviso con sonda ambiente (correzione della temperatura)
Per mantenere una certa pacatezza e correttezza all’interno del sito ho ritenuto necessario eliminare alcune frasi o parole, non prettamente attinenti con l’argomento nè tantomento tecniche, che a mio parere potessero offendere chi è intervenuto nei commenti.
Ringrazio di nuovo tutti per le preziose informazioni!
Per Paolo
“3) Il corpo umano …”
Idem come sopra.
“Inoltre la temperatura di riferimento interna degli ambienti”
Eccellente e precisissima disquisizione, ma una persona la misura con un normale termometro (molti manco hanno quello).
– Certamente Paolo misurare la temperatura operante non è possibile. Relativamente alla misura della temperatura ambiente, che generalmente è possibile sia nelle condizioni a bulbo secco, sia nelle condizioni a bulbo bagnato, risulta sufficientemente facile con vari sistemi analogici, digitali, meccanici, piezometrici, etc etc. Con buona approssimazione anche un termometro da parete può dare una sufficiente indicazione
“4) L’impianto a pavimento non ha un contenuto d’acqua costante, …”
Come per i 100 W ho dato il valore di 1 l/mq; l’equiparazione con il contenuto di un radiatore … troppo da quelle capacità.
– Ecco qui stai già correggendo il tiro, come nell’esempio riportato le variazioni possono essere a volte sensibili, altre volte meno, anche se a conti alla mano a parità di potenza termica da erogare, a mio avviso e da conteggi eseguiti, il radiante avendo più superficie di emissione, per forza di cose ahimè ha un maggior contenuto d’acqua.
“L’inerzia, … le prestazioni possono essere migliorate … ma cls con granulometria in curva di Fuller”
La mia esperienza in cantiere con imprese edili, muratori, posatori di massetti … forse sono fuoriluogo (forse?).
– Paolo il settore della termoidraulica sovente vede intervenire soggetti che con scarsa competenza e preparazione della materia sono poco avvezzi anche ai suggerimenti. Da dire inoltre che per i pavimenti radianti, l’impiego di un additivo (fluidificante e/o superfluidificante) esegue una sensibile interferenza sulle caratteristiche termiche del prodotto a matrice cementizia. La sua unica funzione è quella di intervenire sulla consistenza del prodotto da manipolare (s2-s3-s4 etc cono di Nyquist).
In sostanza la funzione dell’additivo è principalmente quella di far lavorare meno il muratore verso l’opera di “stagiatura superficiale” (o elicottatura nel caso industriale) lavorando incredibilmente sul rapporto acqua/cemento che in condizioni std non è superiore a 0.55 e che impiegherebbe ore ed ore di lavoro creando oneri aggiuntivi. Per esperienza diretta (laboratori MAPEI) nella mia ultradecennale esperienza ho avuto modo di vedere che chi propone l’additivo come un esaltatore delle proprietà termiche paventando un aumento del coefficiente di emissione dell’impianto, in realtà dice delle corbellerie incredibili. Tra il dire (del progettista) ed il fare (dell’idraulico) c’e’ sempre più divario. Sono 20 anni che batto sulla testa degli idraulici sul come eseguire a regola d’arte un impianto radiante, ma la battaglia è sempre dura.
“(ah le unità di misura del tipo menzionato non si usano più …”
– Ahah ti concedo licenza, però devo dire che basta abituare le persone a usare le unità corrette. Sto cercando di trasmettere ad alcuni miei amici installatori che il PCI del metano è il caso di descriverlo in MJ/Nmc anziché kcalh/Nmc. Forza e coraggio.
“5) Le temperature massime superficiali… NON sono le temperature di progetto.”
Non l’ho scritto da nessuna parte che siano temperature di progetto, ma le … Vero, ma nell’ambito abbastanza … di differenza.
– Era una mia puntualizzazione; da dire però che se la descrizione di una legge tra temperatura dell’aria-temperatura del pavimento (o temperatura equivalente di mandata) o potenza areica emessa è espressa da una equazione non lineare, approssimarla a lineare rilascia certamente dei margini di errore. Io da tecnico preferisco la prima. E’ cmq una procedura estremamente diffusa nella fisica tecnica ambientale per la valutazione anche dei carichi termici estivi/invernali.
“8) … si potrebbe arrivare anche a 135 W/mq, 150 W/mq lungo le superfici marginali.”
Hai pienamente ragione, ma spesso queste fasce perimetrali con serpentine più fitte creano difformità della temperatura… alcune superfici.
– Beh essendo valori massimi generati da elevate dispersioni dei ponti termici lineari, a basse dispersioni corrispondono anche basse temperature pavimentali. Per logica tecnica la posa variata a zone la suggerisco.
“9) Nel raffrescamento a pavimento l’impianto inverte il suo ciclo funzionale, …”
Senza scomodare specialistiche regolazioni programmabili e costosi servocomandi 0/10 V, Honeywell ha … con uscita 3 punti per…
– Se parli della regolazione CN2CHR honeywell con sonda ambiente AQ6000, onestamente ho sempre ottenuto risultati modesti di gestione, ha molte limitazioni. Preferisco la DIGIT della Nest più intuitiva e meno farraginosa sulla gestione anche multizona (diversamente carel)
“11)… L’esempio numerico descritto può avere senso ai fini della velocità dell’acqua … a regime dell’impianto”
Non capisco il nesso tra la velocità dell’acqua all’interno del tubo … dipende da altro.
– Andando oltre gli aspetti legati alla rumorosità e al carattere del moto all’interno della distribuzione, la velocità dell’acqua all’interno del tubo interviene sulla cessione di calore da parte della distribuzione al massetto in cls. Il massetto si comporta come un grande scambiatore che a contatto con una serie di elementi lineari a temperatura più elevata asporta calore più o meno velocemente a seconda della velocità con la quale il fluido caldo scorre dentro le tubazioni.
“… scegliere pompe con Q-Hp sproporzionate rispetto alle portate/prevalenze necessarie e quindi costose.”
Nell’ambito civile, ma anche quello industriale, degli impianti a pavimento penso che il dimensionamento della pompa … visto anche le modeste prestazioni normalmente richieste.
– Vero che le applicazioni valgono sia per l’ambito civile sia per quello industriale. Ritengo invece che l’NPSH della pompa debba essere verificato con la curva caratteristica della macchina a rotore bagnato onde evitare, visto il fenomeno che hai ben descritto, di farla lavorare sopra o sotto battente (nel caso ad esempio di pompa unica di centrale termica con impianto radiante su più zone e più livelli). Tra l’altro non sempre le prestazioni richieste sono limitate, possono magari esserlo per la portata volumetrica, ma magari non lo sono per la prevalenza.
In fase progettuale una bassa portata non significa avere sempre una bassa prevalenza. Inoltre fissando le perdite di carico dell’impianto ai 2000-2200 daPa, alle quali vanno sommate quelle localizzate del collettore di distribuzione, quelle uniformemente distribuite delle distribuzioni (che variano con legge quadratica) e quelle localizzate di valvole, gomiti, saracinesche etc etc arrivare a quella più sfavorita nella misura dei 2500-3000 daPa non è poi così impossibile.
“12) Relativamente alle differenze tra i sistemi su pannello liscio o su pannello bugnato, i … se si arriva al 2% è tanto”
Grazie della conferma. Avresti qualche link sull’argomento?
– Prova a vedere nel sito della RDZ; quando lavoravo per loro mi dilettai a fare degli studi in tal senso. Forse han ancora pubblicato qualche cosa. Oppure guarda la manualistica tecnica delle REHAU; per anni sono stato il loro consulente termotecnico e hanno della documentazione di progetto ben fatta. Dai una sbirciata anche alla Nest Italia, la loro documentazione è discreta. Non disdegnare ovviamente la Velta.
Ne approfitto per una domanda: cosa ne pensi degli isolanti multi-layer riflettenti per impieghi abbinati a sistemi radianti? L’elevato valore … termica dichiarata?
– Caro paolo, le tecnologie multi-layer impiegate per i sistemi radianti sono cosa ormai a mio avviso superata, giacchè sfruttare il fenomeno della riflettanza di superfici opache (tra l’altro sia con materassini specifici, sia nella tubazione pentalayer) allo scopo di ottenere maggiore resa dell’impianto, a conti fatti non produce grossi risultati dal punto di vista delle prestazioni.
A fronte pero’ di un costo specifico a mq certamente superiore, il gioco secondo me non vale la candela. Inoltre, come già hai intuito, le caratteristiche di resistenza e quindi di conducibilità termica, raramente si mantengono costanti nel tempo, giaccè nei diagrammi di durabilità temperatura-tempo di tanti produttori, si fa riferimento a condizioni di laboratorio e sovente anche su transitori temporali molto limitati.
Inoltre i carichi ciclici riscaldamento/raffreddamento sul materiale e soprattutto nel lungo periodo non possono, intuitivamente, non avere un effetto negativo con penalizzazione delle prestazioni del materiale. Da non dimenticare che la penetrabilità (porosità) di determinati materiali all’ossigeno sovente inficia le caratteristiche degli stessi durante l’esercizio dell’impianto oltre che alla sua funzionalità.
Per Luca
Oltre a cio’ che ti ha detto Paolo che è corretto, il diametro del tubo basso non implica consumi di fluido termovettore (acqua), ma bensì richiede maggiore spinta idrodinamica da parte della pompa sul fluido.
In buona sostanza, chi ti vende i pannelli per l’impianto a soffitto, ti deve dare anche la massime perdite di carico che il termotecnico (si spera esista) impiegherà per individuare la pompa più adeguata all’impianto.
In genere comunque le pressioni di esercizio a freddo sono di circa 1 bar a caldo al massimo 3 bar, allo scopo di stare sotto i dispositivi di sicurezza previsti per gli impianti (3 o 3.5 bar dipende dai costruttori dei generatori di calore).
Sulla scelta del radiante a soffitto rispetto al pavimento, i criteri di scelta dipendono anche dalle soluzioni architettoniche adottate dal costruttore o chi per esso (utente). E’ meno inerte, i gradienti termici sono tollerabili e la risposta è certamente positiva sia sul caldo, sia sul freddo. La variabile maggiore è il costo, alcune aziende lo propongono al doppio del pavimento e poi dipende sempre dall’idraulico che te lo vende.
Io in tutti questi anni ho valutato parete, pavimento e soffitto. Ciascuno ha dei plus che a mio avviso vengono esaltati a seconda dell’applicazione richiesta.
Ricorda pero’ di non vanificare i benefici del radiante a soffitto e quindi del rendimento medio stagionale posizionando poi nei servizi igienici dei termoarredi (scaldalviette) che lavorano ad alta temperatura :-) Usa alluminio.
Interessanti gli interventi, tutti. Mi riservo di entrare nei dettagli tecnici (capirci qualcosa), ma penso di averne afferrato il senso.
Dai diagrammi prospettati nei link parrebbe che le due soluzioni ottimali siano il riscaldamento a pavimento e il riscaldamento a parete. Del primo si è detto tanto, anche se permangono in me parecchie perplessità su quanto detto.
Del tipo:
– il pavimento da usare, perché si parla solo di maiolica (per lo spessore, forse) quando abbiamo tanti esempi di vecchi pavimenti (vedi il cotto) che non sono mai freddi;
– ancora, il massetto; l’inerzia termica offerta favorirebbe un materiale quale l’argilla e/o altri (salvo per lo spessore).
– Del secondo tipo di impianto (a parete) non si dice che la parete viene sfruttata spesso per sorreggere qualcosa (vedi i quadri) con necessità di fare fori (piccoli e/o grandi). Catene portanti dall’alto? Chi le accetterebbe?
La soluzione meno performante parrebbe quella a soffitto. Il caldo tende a rimanere in alto. Non sarebbe utile un impianto di messa in circolo dell’aria, non un ventilatore quanto piuttosto un turbogetto o altro di simile?
Per Giovanni
– In genere il pavimento (rivestimento) superficiale maggiormente adatto per gli impianti radianti è quello che tecnicamente offre meno resistenza termica alla conducibilità di calore del massetto sottostante. Si possono usare quindi rivestimenti ceramizzati (maiolica, gres porcellanato, argilla, etc) marmorei e granitici.
Ho avuto ad esempio interessanti prestazioni su pavimenti a terrazzo veneziano molto complessi dal punto di vista della loro costituzione (e spessore). Si può usare il legno (abete, ciliegio, castagno, etc).
In genere, oltre a considerare la resistenza termica del rivestimento (dato tecnico del produttore), è da non dimenticare che lo spessore può incidere sulle grandezze dimensionali dell’impianto (portata di progetto, temperatura di mandata impianto, perdite di carico). La norma dà delle indicazioni in tal senso ed è stato riportato un dato del tipo 0.1 w/mqK che è il riferimento sotto il profilo dimensionale (in sostanza quello teorico).
A volte il problema che si manifesta soprattutto ad esempio sui pavimenti a base lignea o legnosi, è legato alle dilatazioni termiche alle quali i materiali per loro legge costitutiva sono soggetti. Il coefficiente di dilatazione volumetrica di un materiale dipende dalla sua costituzione e quindi non è sempre di semplice determinazione.
– Il calcestruzzo di cemento stesso di cui è costituito il massetto sul quale poi viene posato il rivestimento (o su caldana di allettamento o in taluni casi anche incollato se sussiste una stagiatura perfetta) è soggetto a ritiro termoigrometrico. Tale ritiro purtroppo si va poi a scaricare sulla pavimentazione sovrastante attraverso una concentrazione di tensioni superficiali (che nella scienza delle costruzioni vengono chiamate coazioni elastiche) che possono danneggiare il rivestimento stesso.
Questo effetto viene tenuto sotto controllo (giacchè non si può eliminare) o con reti elettrosaldate 10/10 o 20/10 localizzate verso la pelle del getto e quindi quella maggiormente esposta all’aria durante il ciclo della maturazione o in altri casi con fibre di tipo:
a) polimerico o polpropilenico
b) acciaio FE 360
c) vetro (cls GRC)
Con questo vorrei dire che oltre alla limitazione dello spessore che l’utente deve considerare, grande importanza riveste anche la posa stessa della pavimentazione.
Esistono delle regole tecniche per evitare di avere sgradevoli effetti superficiali del pavimento che si potrebbero enunciare. Regole più da pavimentista che da utente finale, il cui interesse ultimo è la funzionalità del suo impianto. Considera che nel settore civile gli spessori di massetto previsti (che variano sulla base del distributore dell’impianto) possono variare dai 2 cm (sistemi detti in basso spessore o SLIM) ai 4-5 cm (sistemi standard). Considera però che per i sistemi a basso spessore il tipo di calcestruzzo di cemento impiegato, come dicevo nei miei post precedenti, deve avere caratteristiche meccaniche a compressione ben specifiche. Anche perché il massetto diventa a quel punto una lastra sottile le cui sollecitazioni meccaniche secondo DSV non sono soltanto quelle di compressione sulle fibre superiori e di trazione sulle fibre inferiori. Ai lati, soprattutto ove esistono elementi di carico (armadi, mobili pesanti addossati alle pareti, etc etc), insistono anche effetti di tipo torsionale non trascurabili.
Sul radiante esistono poi anche sistemi a secco, nel senso che non usano prodotti a matrice cementizia (e quindi bagnati) in grado di ottenere anche spessori più ridotti (pannello isolante con incavi per la distribuzione da 14×1 mm e lastra in acciaio termoconduttrice) e sui quali magari è meglio parlarne in altro post.
– Vero che nei post precedenti, quando si parlava di parete, alcune informazioni sono “scappate”. Il parete rispetto al pavimento ha meno superfici impegnate dal punto di vista della reazione dell’impianto, in quanto essendo meno inerte genera maggiore cessione di calore in ambiente a parità del fabbisogno del locale.
Su questa base la superficie di emissione necessaria per soddisfare tale fabbisogno è minore e quindi facilmente localizzabile. Ovvio che sulla parte in questione non bisognerebbe poi addossarvi armadi, mobili, quadri ed altri oggetti che creerebbero delle inutili resistenze termiche a svantaggio dell’impianto stesso.
La scelta della parete (o delle pareti) più idonee per l’impianto diventa a questa punto una condizione progettuale. Così come ad esempio anche per il pavimento grandi superfici coperte da tappeti (o addirittura moquette) sono vivamente sconsigliate.
Chi decide di realizzare un impianto radiante a parete o pavimento deve essere a conoscenza che sussistono comunque delle condizioni applicative che possono limitare una certa libertà di arredo interno. Sotto questo profilo il soffitto non avrebbe invece alcuna limitazione.
Mi piacerebbe capire come calcolare la potenza erogata dal riscaldamento a pavimento.
Immagino esista una formula che sia funzione del passo dei tubi e del loro diametro.
In altre parole dovrebbe essere funzione della quantità di acqua calda che circola in un determinato locale/abitazione e che deve essere proporzionale alla dispersione termica del locale/abitazione stesso a sua volta dipendente dal grado di isolamento dell’involucro.
Inoltre sempre in tema di riscaldamento in bassa temperatura, vorrei chiedere, se possibile, qualche considerazione sui pannelli radianti in BT in alluminio come alternativa al riscaldamento a pavimento per quelle situazioni in cui non è possibile installarlo per diverse motivazioni (altezze non disponibili, impossibilità economica nel rifare intermante i pavimenti ecc).
Mi chiedevo se la loro resa è analoga, ovviamente a parità di potenza erogata, a quella del pavimento radiante, sia in termini di efficacia termica che di comfort abitativo.
Se la risposta è affermativa, considerando la grande inerzia termica del riscaldamento a pavimento, non sarebbero da preferire le piastre radianti, anche in virtù della loro poca invasività in termini dei lavori che devono essere effettuati per la loro installazione, se paragonati al riscaldamento a pavimento, in particolare nel caso delle ristrutturazioni?
In questo caso supponendo che le abitaizoni siano già dotate di termosifoni (ghisa o altro) sarebbe semplicemnete ipotizzabile sostituirli con le piastre radianti in BT, ovviamente dopo aver deteminato la potenza necessaria, funzione come detto del grado di isolamento dell’edificio.
Quali sono gli svantaggi e le controindicazioni sia del pavimento radiante che delle piastre radianti a parete?
In accordo con la UNI 1264 il flusso di calore è:
Q = S x deltaT x B x Fp x Fi x Fm x Fd
ove:
S = superficie del pannello
delta T = media logaritimica tra temperatura del pannello e temperatura ambiente
B = fattore relativo alle caratteristiche del tubo
Fp = fattore relativo alla resistenza termica del pavimento
Fi = fattore relativo all’interasse dei tubi
Fm = fattore relativo allo spessore del massetto sopra i tubi
Fd = fattore relativo al diametro esterno del tubo
Se per pannelli radianti in alluminio intendi piastre radianti e/o radiatori in alluminio la loro resa deve essere conforme alla UNI EN 442 ove viene fissato il delta T tra la temperatura dell’aria e la temperatura del corpo scaldante massima. Hai meno superficie installata e quindi a parità di fabbisogno maggiore emissione specifica. Il criterio di scelta dipende non solo da una questione tecnica, ma anche economica.
Se esistono già dei corpi scaldanti in ghisa, dopo avere verificato il fabbisogno del locale e dimensionato il corpo scaldante per la bassa temperatura (delta T 20°C cf UNI EN 442) grandi problemi non ci sono.
Verificare anche se le tubazioni in ingresso ai singoli corpi scaldanti sano in grado di sopportare le portate di progetto. I vantaggi e gli svantaggi tra pannello radiante/radiatore credo siano già stati affrontati.
Riguardo al pavimento radiante, (per edifici di classe energetica A-B e per le zone climatiche a-b-c-d ) preferisco l’installazione di radiatori a bassa temperatura ed ad alto contenuto d’acqua.
Per classi energetiche A+ (reali!) non vi è la necessità.
Buongiorno a tutti.
Complimenti per il bel blog e per i commenti davvero illuminanti.
Sto realizzando una ristrutturazione di una vecchia cascina e mi sono reso conto di quanta superficialità e impreparazione vi è da parte di molti (non tutti, ma ancora non li ho trovati) installatori.
Scelta progettuale con caldaia a condensazione e pannelli radianti.
Avrei alcuni chiarimenti da portare alla vs attenzione:
1 – Regolazione riscaldamento a pannello radiante: non mi è chiaro il discorso relativo all’uso o meno di cronotermostati e testine. Da più parti si consiglia di non utilizzarle, qualcuno potrebbe spiegare in termini “semplici” i motivi e quali sono le modalità di gestione alternativa?
Il mio termotecnico a capitolato ha inserito: n. 12 cronotermostati ambiente a programmazione settimanale (Honeywell CM907i) e n. 24 testine termostatiche ti tipo NC.
2 – Soluzione a secco: abbiamo deciso per il parquet in tutta la casa. Chiaro che siamo consci del fattore isolante, però si vive anche di sensazioni e quelle del parquet non le trovi con la porcellana. Detto questo, sappiamo di dover probabilmente incrementare la temperatura di mandata e forse infittire il passo delle tubazioni.
Oltre ciò però la nostra scelta prevede una installazione a secco del parquet che viene inchiodato su pannelli di fermacell da 1.5 cm i quali sono posati su sabbia di fiume stagiata. La stratigrafia prevede che sopra il bugnato con i tubi sia posato uno spessore di circa 2,5 – 3 cm di sabbia di seguito il fermacell e il parquet. In effetti detta così sembra un controsenso. Il fornitore è sembrata persona preparata e molto seria. Ha certificazioni del Politecnico di Torino che confermano il fatto di poter scaldare come un massetto tradizionale. Che ne pensate? Probabilmente si devono alzare le temperature ed infittire i passi ulteriormente.
3 – Riscaldamento a Parete: potrebbe essere una soluzione per limitare l’umidità dei muri dovuti alla risalita capillare?
Grazie e buon anno a tutti.
Per Silvio (in parole semplici) :-)
1 – La regolazione per l’impianto radiante è costituita da:
a) regolazione della temperatura di mandata ai pannelli radianti;
b) regolazione della temperatura ambiente.
Per quanto concerne il punto a) la regolazione può essere costituita da valvola miscelatrice con sonda di mandata alimentata elettricamente da una centralina in grado di gestire una curva climatica (temperatura ambiente-temperatura di mandata-temperatura esterna).
Per quanto concerne il punto b) il tuo termotecnico ha adottato per ogni ambiente un controllo di temperatura che agisce sui circuiti di ogni ambiente attraverso delle testine elettriche (24/230V) che si aprono o chiudono in funzione della temperatura ambiente richiesta. Questa soluzione che io non condivido affatto crea problematiche di tipo:
– di installazione (l’elettricista nella grande maggioranza dei casi sbaglia sempre i collegamenti elettrici cosicchè l’idraulico per fare funzionare l’impianto è costretto a staccarle dalle mandate ai circuiti lasciando il passaggio pieno al fluido caldo ovviamente senza bilanciarle);
– di temperatura ambientale (che senso ha in casa avere per ogni ambiente una temperatura diversa controllabile da ciascun termostato). Da un mio punto di vista se proprio non se ne può fare a meno, divisa in due zone (zona giorno e zona notte);
– economico (moltiplica il costo delle teste elettriche + cavi elettrici di collegamento + manodopera elettricista).
Ho fatto decine di esperimenti sui radianti a pavimento e pensa che con una buona caldaia a condensazione in grado di modulare dai 20 agli 80 °C secondo la curva preimpostata generalmente bassa (0.8 – 1.0) si ottiene in senso proporzionale una temperatura di mandata sufficiente a soddisfare il comfort (e senza tutti i termostati ambiente).
In buona sostanza l’impianto, se poi scegli per i servizi igienici termo-arredi a bassa temperatura, diventa MONO temperatura e quindi il rendimento dell’impianto risulta più elevato.
Non voglio però fuorviare la decisione presa dal termotecnico. Ogni progettista ha la sua filosofia di progettazione degli impianti.
Se fosse casa mia posizionerei al max due termostati di zona e lascerei lavorare l’impianto senza intermittenza (al massimo con una leggera riduzione notturna due gradi in meno rispetto alla temperatura diurna).
2 – Le soluzioni a secco ben si prestano su tante situazioni, però hanno anche un costo specifico a mq molto elevato rispetto al sistema tradizionale. Vista la configurazione del prodotto che hai scelto, il tuo termotecnico avrà calcolato l’impianto con la resistenza reale e definito il flusso massimo di calore per l’ambiente (in caso di necessità si infittisce il passo e si aumenta la temperatura di mandata, però sono soluzioni che inficiano il rendimento perchè avresti due zone a temperatura di progetto abbastanza diverse l’una dall’altra). Il fermacell, la sabbia ed il pavimento creano una resistenza notevole, però se possiedi la certificazione del fornitore del sistema :-)
3 – L’impianto a parete non è, in caso di infiltrazioni capillari lungo le perimetrature o le partizioni interne, il vaso di pandora. Potrebbe essere un coadiuvante nel senso che può limitarne la formazione, ma non eliminare completamente il fenomeno. Le cause di infiltrazione capillare in genere sono più serie e raramente si risolvono con uno specifico impianto.
Benvenuti nel 2013!
Mi pare che tutti stiano facendo troppa teoria filosofica sull’argomento.
Progetto da sempre gli impianti radianti e francamente di molte finezze si può fare a meno.
Vi invio alcune dritte da praticone.
Nel 1988 ho progettato e installato un riscaldamento a pavimento in un appartamento al 4 piano di un palazzone da 12 realizzato negli anni 60 privo di ogni forma di risparmio energetico. Ho ottenuto subito un consumo energetico dell’alloggio pari ad un quarto rispetto agli altri.
Nel 2004 ho sostituito la vecchia caldaia a gas (comunque ancora con un rendimento al 95%) con una a condensazione ed ho tolto ancora un buon 50% di consumo.
Come procedere:
1) ISOLARE BENE: controfoderare l’alloggio a 6 lati (perdere pochi cm perimetrali non è un dramma). Ho sventrato tutto ed eliminato perfino la parete di foratelle interne della parete a cassetta perimetrale.
2) TAGLIARE I PONTI: eliminare tutti i ponti termici con pignoleria (ho perfino rivestito di isolante tutti i pilastri e le travi dell’alloggio). Sembra eccessivo ma i ponti termici sono il tallone di Achille di molte ristrutturazioni.
3) PROGETTARE CON TECNICI PREPARATI: realizzare gli impianti radianti con una progettazione molto accurata e dettagliata per eliminare parallelismi pericolosi e punti di addensamento – per esperienza ho visto impianti realizzati con ottimi materiali ma con rendimenti pessimi per errata progettazione.
4) CONTROLLARE LE TEMPERATURE:
a) dotare tutti circuiti di valvole termostatiche di regolazione e chiusura del singolo circuito (personalmente, nel 1988, ho trovato molto buona la soluzione di portare nel muro della stanza un ricciolo del circuito inserendo a muro la classica valvola termostatica) – Non siate tirchi e utilizzate le valvole di ultima generazione più precise e rapide, avrete ottimi riscontri di qualità ambiente ed economici.
b) inserire sempre cronotermostati con regolazione settimanale per il circuito della bassa temperatura e per quello della media.
c) posizionate una sonda climatica esterna curando pignolescamente la posizione e se del caso realizzando una strutturina di protezione
5) DOPPIO CIRCUITO: per i bagni doppio circuito. Comunque quello a pavimento e poi uno da mandare a temperatura media (60°) e non alta per alimentare dei generosi scaldasalviette (hanno la funzione principale di permettere alle signore di asciugare il bucato in situazioni di emergenza e di innalzare la temperatura fin ai 24 °C per le abluzioni di piccoli e mamme freddolose.
6) DI NUOVO CONTROLLO DELLE TEMPERATURE: l’impianto deve avere un DIM con centralina di gestione dell’impianto con caldaia combinata (riscaldamento + produzione di acqua calda sanitaria), suddiviso in due zone di cui una a bassa temperatura (pannelli radianti a pavimento) ed una ad alta temperatura (bagni). La temperatura dell’acqua di mandata sulla zona a bassa temperatura sarà regolata da trimmer (circa 38-40°), la temperatura dell’acqua di mandata per la zona a media temperatura dipende dal tipo di caldaia a condensazione scelta e si terrà alla temperatura ottimale di funzionamento indicata dalla ditta. La mandata a 40 gradi immetterà nel collettore di distribuzione acqua a circa 28 gradi e l’acqua di ritorno dai circuiti al collettore sarà a circa 21 gradi.
7) MANUTENZIONE ANNUA seriamente applicata!! Sia alla caldaia che a tutte le altre componenti.
Vi è poi tutta la serie di indicazioni, per carità, corrette dal punto di vista teorico, ma percentualmente poco influenti soprattutto perché ampiamente meno significative dei comportamenti d’uso e gestione degli occupanti l’alloggio. Molte pessime abitudini sono difficili da eradicare e vanificano molte delle sofisticate scelte progettuali possibili teoricamente.
In pratica:
a) Contrariamente a quanto scritto nei sacri testi, meglio divisori e strutture leggere (cartongesso) e l’isolamento a stretto contatto con l’interno dell’abitazione (almeno per le nostre zone climatiche dell’Italia centrale)
b) i pavimenti possono essere di qualsiasi tipo (ceramica, legno, moquette, ecc.) non vi è alcuna controindicazione
c) i mobili possono essere disposti ovunque mentre le spirali devono occupare interamente la superficie pavimentata
d) meglio gettare il massetto bonificato e pavimentare l’alloggio prima di realizzare i divisori (personalmente ho un pavimento in legno da 20 mm posato su tutta la superficie dell’alloggio prima di realizzare le pareti in cartongesso e vi garantisco che va benissimo)
e) l’impianto si accende a Novembre e si spegne a Maggio (in realtà è spesso fermo autoregolato dalle sonde e dalla centralina)
f) l’attenuazione notturna è di 2 gradi (19,5 gradi di giorno e 17 di notte). Le temperature possono sembrare basse ma non è così perché avendo tutte le superfici degli ambienti a temperatura il confort è garantito. La sensazione di freddo è data dalla presenza di pareti o vetrature “fredde” che assorbono l’irraggiamento corporeo e non già dalla temperatura dell’aria che spesso è superiore di alcuni gradi rispetto alla temperatura “percepita” dalle persone
g) abbassare le tapparelle, chiudere le tende, non arieggiare per ore gli ambienti, non giocare con i termostati in continuazione per dare tempo all’impianto di autoregolarsi son tutte cose ovvie, ma molto difficili da ottenere dagli utenti.
Di tutte le altre cose si può far meno conto.
Fidatevi ho 24 anni di esperimenti sulle spalle.
Ciao Cesare e grazie per il tuo contributo.
Ho qualche perplessità quando affermi “… meglio divisori e strutture leggere (cartongesso) e l’isolamento a stretto contatto con l’interno dell’abitazione (almeno per le nostre zone climatiche dell’Italia centrale)“.
Specialmente alle nostre latitudini e con impianti di riscaldamento di tipo continuo come può essere un impianto a pavimento radiante, ma soprattutto per la problematica del surriscaldamento estivo di cui si sente poco parlare, ma che di primaria importanza, a mio parere e non solo, ritengo che sia più opportuno utilizzare materiali ad alta capacità termica areica sul lato interno dell’involucro edilizio.
A sostegno di questo ti rimando ad alcune pubblicazioni nazionali e internazionali scaturite da una mia ricerca scientifica sperimentale:
– Interzia Termica: Come Migliorare il Comfort Termico in Fase Estiva
– Influence of the internal inertia of the building envelope on summertime comfort in buildings with high internal heat loads
– Massa e comfort: necessità di una adeguata capacità termica areica interna periodica
Caro Cesare,
magari non sei neanche l’unico che ha un sacco di anni di esperienza e non è per contraddirti anche perchè dici cose certamente risapute e che prima di te forse abbiamo anche scritto e riscritto.
D’altro canto il mio primo impianto di riscaldamento a pavimento lo progettai nel 1992, 4 anni dopo di te. Quindi anche se la pratica ha la sua corretta connotazione, per favore non minimizziamo la questione progettuale ed affrontiamola anche dal punto di vista teorico nel modo giusto così come io, paolo ed altri abbiamo fatto. Questo per evitare che il generico idraulico coi suoi soliti 100 W/mq mi vada a dimensionare la potenza termica istantanea della caldaia.
Concordo pienamente con l’obiezione dell’ing. Ursini relativamente alla questione dell’isolamento.
Cordialità
Concordo con L’ing. Vietri pienamente, la progettazione dettagliata e puntuale è indispensabile così come una direzione lavori esperta e severa. Ho visto danni incredibili fatti dai soliti idraulici pasticcioni. Mai si può prescindere da un’attenta verifica teorica preliminare.
Sono stato frainteso, il mio intento era solo quello di focalizzare l’attenzione dei progettisti (ripeto dei progettisti e non dei “fai da te”) sulla necessità di porre l’attenzione sulle mille variabili presenti di ogni intervento. Questo perché mi è spesso capitato di dover vedere pessimi impianti realizzati in base a progettazioni esatte ma troppo teoriche.
Scusate il fraintendimento.
Anche per quanto riguarda il problema della “masse” sono stato mal comprese. Intendevo solo dire che a parità di budget per me sono più importanti certe scelte che altre.
Cordialmente
Desidererei un Vs parere.
L’unico motivo che conosco per non usare tubazioni in rame 14 x 0.8 negli impianti radianti è il costo del materiale e la maggior manodopera per la posa, ma in parte recuperati dalle minori quantità necessarie.
Voi ne conoscete altri? E motivi per utilizzarlo oltre alla durata?
Buongiorno,
ho ristrutturato caso e ho fatto installare un riscaldamento a pavimento.
La casa è su tre piani: taverna, cucina-sala, zona notte all’incirca 40 metri per piano.
L’idraulico che mi ha fatto l’impianto mi ha installato dei collettori privi di flussometri senza alcun disegno dell’impianto come mi devo comportare?
Sono necessari i flussometri?
Va bene avere un elettrovalvola per piano?
Visto che deve ancora farmi dei lavori e quindi devo ancora pagarlo come mi devo comportare?
Volevo fare una domanda. quanti cm da sopra limpianto pavimento cioe da i tubi a pavimento finit0 compreso di massetto. Grazie mille.
@Marco
Di solito il massetto copri impianto va dai 5 ai 6 cm. Aggiungici 1 cm di pavimento (sia in ceramica che in legno) e ottieni il totale di 6÷7 cm.
Se pensi di ridurre lo spessore del massetto ti consiglio un autolivellante, con il quale puoi arrivare al MASSIMO a 3 cm.
Salve ho un impianto a pavimento su due piami totale 180mq, gestito con pompa di calore esterna aria aria, non si riusciva a gestire il tutto con gestione pompa impianto tramite termostato, troppo il tempo di risposta lettura calore da esso x accensione della pompa quindi un tempo di ripresa e uguale perdita di connessione al massdetto.
Il mio primo suggerimento e quello di alternare la pompa in gestione bassa ma continua in modo di non abbassare mai il calore del massetto, ora sto x realizzare un modo di gestione di pompa diretta alla risposta del pavimento, tipo una sonda tipo acquario in un contenitore posato sul pavimento con acqua dove la sonda leggera la temperatura e trasmetta alla pompa un immediata risposta.
Non sono un professionista ma ho esperienza su impianto riscaldamento abitazione e capannone di acqua da falda
Vorrei chiedere un consiglio: ho un impianto a pavimento alimentato da caldaia a gas a condensazione; sopra il pannello radiante ho un pavimento di tipo industriale costituito da 9 cm di massetto autolivellante.
A causa dell’alto spessore del massetto, vorrei chiedere? Ha senso utilizzare il cronotermostato con fasce orarie o è meglio impostare una certa temperatura in modalità manuale e lasciare sempre quella?
Grazie
Gentile sig Floriana,
generalmente spessori così elevati di massetto sopra l’impianto vengono realizzati per applicazioni industriali e non civili comunque per entrare nel merito della Sua
richiesta:
1 – l’inerzia termica dell’impianto è proporzionale a quello che ci sta sopra. In altri termini maggiore è lo spessore dei materiali sovrastanti, maggiore è la
resistenza che l’impianto deve vincere per entrare in temperatura (attivazione della massa termica). Di solito negli impianti civili il decadimento termico tra la riduzione diurna e notturna o comunque definito da fasce orarie di riscaldamento, non è mai molto elevato. Ad esempio 19°C diurni e 17°C notturni, questo perchè poi la messa a regime al valore diurno risulti meno lunga ed accettabile per il comfort del cliente;
2 – a causa dell’elevato spessore del prodotto a matrice cementizia oltre ad avere tempi lunghi di messa a regime, un decadimento termico sensibile non sarebbe
accettabile per le tempistiche di sfasamento termico tra la temperatura diurna e quella di riduzione. In sostanza quando la massa si è attivata al valore di temperatura di setpoint scelta per il funzionamento diurno si correrebbe il rischio di andare in riduzione a causa magari degli orari preimpostati e quindi delle temperature di setpoint selezionate;
3 – inoltre a causa del considerevole spessore sovrastante la massa termica impiega più tempo ad attivarsi e certamente anche più tempo per decadere termicamente. A questa condizione corrispondono tempi di attivazione che potrebbero essere di parecchie ore se la riduzione notturna fosse sensibile (tra i 2-3°C);
4 – quindi per le tempistiche indotte dall’attivazione della massa vista la sua elevata inerzia per lo spessore indicato e visto che certamente per non correre il rischio di creare disagi tra il funzionamento diurno e quello ridotto che presupporrebbe di avere forse delta T ancora inferiori a quelli indicati per le civili applicazioni, le converrebbe piuttosto stabilire un unico regime di funzionamento del suo impianto con temperature inferiori;
5 – riepilogando: gestisca un’unica fascia oraria diurna o addirittura giornaliera con una temperatura ambiente impostata di 18-18,5°C e lasci funzionare il suo impianto il più a lungo possibile. Se vuole assolutamente delle riduzioni notturne si accerti che almeno la fascia ridotta sia di 8-10 ore per consentire al suo impianto di decadere, andare in riduzione notturna e di risalire termicamente alla fascia diurna.
Cordiali saluti
La ringrazio moltissimo per la tempestività e la chiarezza della sua risposta.
Ricambio i saluti,
Floriana
Salve a tutti,
vi chiedo,per cortesia, di aiutarmi a capire un pò meglio come impostare il riscaldamento a paviamento della mia nuova casa visto che ad oggi ho un consumo di circa il 50% maggiore dell’appartamento, identico, a fianco del mio. Un pò di dati:
– abitazione di circa 80mq, sala+angolo cottura, 2 camere 2 e 2 bagni, classe A esposto a sud-est (al contraio dei vicini che sono esposti a nord-ovest), al sesto e ultimo piano di un condominio di 24 appartamento totali a Bologna. Termostato in ogni stanza regolati intorno ai 21 gradi costanti in tutte le stanze (così come i vicini);
– riscaldamento a pavimento con microgeneratori+integrati da caldaia a condensazione+sonda esterna con contacalorie per ogni appartamento. L’appartamento è nuovo e l’impianto è stato acceso per la prima vaolta da crica 5 settimane;
– a quanto dice l’impiantista l’impianto è predisposto per avere una mandata a 40° con temp esterna a -5° e questo per consentire di avere l’acqua calda anche al 6 piano, è corretto? Io vedo che l’acqua mi arriva al 6 anche a 40% come se non ci fosse troppa dispersione;
– la portata è a 2ltmin per tutti i flussometri;
– nella zona giorno nelle ore diurne il flussometro raramente è aperto mentre si accende più spesso nella zona notte (più lontana dal punto di entrata dell’acqua visto che i tubi devono attraversare la zona giorno);
Domande:
– concettualmente è meglio avere una portata ridotta (ed immagino in questo caso i flussometri aperti per più tempo) o elevata (e quindi flussometri chiusi per più tempo).
– dove dovrei avere la maggiore portata?
– come potrei procedere alla corretta regolazione della portata?
– è consigliabile una riduzione della temperatura di mandata?
Scusate se informazioni non sono troppo tecniche, non ne capisco molto.
Grazie a tutti per l’aiuto che vorrete darmi
Gianluca
Egregio Gianluca,
per entrare subito nel merito dei quesiti da te posti:
– la maggiore portata volumetrica la devi avere dove sono localizzate le maggiori dispersioni termiche globali (trasmissione+ventilazione): Certamente all’interno della tua abitazione avrai ambienti che disperdono di più d altri che disperdono di meno, quindi dispersioni maggiori porta portate maggiori;
– la corretta regolazione della portata se sulle teste dei collettori sono localizzate dei flussimetri è da realizare prima tarando ciascun circuito sula portata di progetto impostare la temperatura dl locale a 20°C e verificare se tale setpoint viene raggiunto. Se non viene raggiunto aumentare la portata, se si supera diminuire la portata (agendo sempre sul flussimetro);
– una riduzione ella temperatura di mandata dipende sempre alle condizioni di comfort ambientale che assieme al risparmio energetico sono due degli obiettivi importanti da centrare con un impianto radiante. Puoi ridurre la temperatura di mandata ad un livello tale per te sostenibile prima che sopraggiunga il disagio della sensazione di freddo che potresti percepire grazie alla riduzione. devi andare per tentativi successivi fino ad individuare il valore corretto di temperatura ambiente che più ti aggrada. Da quel che ho letto il tuo setppoint ambiente è di 21°C che generalmente sarebbe un po’ altino per impianti radianti che lavorano su superfici molto ampie. L’ottimizzazione dell’impianto è tale per cui tu debba avere oltre al comfort anche risparmio rispetto ai sistemi tradizionali, quindi prova ad abbassare la temperatura ambiente a 20°C e valuta la tua sensazione di comfort, se stai ancora bene a 20°C riduci a 19°C. Considera che in media per ogni °C in meno di temperatura dell’aria riscaldata corrisponde a monte del sistema un risparmio energetico di di circa il 7%. Quindi abbassa la temperatura e fai funzionare l’impianto più a lungo, questo ti consentirà di avere comfort e risparmio energetico.
Considera che la temperatura di mandata al sesto piano è notevolmente influenzata dalla dispersioni termiche della linea di adduzione dalla centrale termica al collettore di distribuzione che hai in casa. Se le colonne sono state isolate bene (perlomeno a norma di legge) non hai grosse dispersioni e quindi dalla centrale termica fino al sesto piano potresti perdere pochi gradi (es 42-43 di mandata e 40 al collettore) se fossero invece isolati male moltiplica le perdite per o per tre addirittura.
Spero di esserti stato d’aiuto.
Gentile Gennaro,
grazie mille per la risposta,mi aiuta molto a capire meglio dove agire per minimizzare i consumi e emassimizzare il comfort.
Purtroppo non posso regolare la temp di mandata in quanto l’impianto è condominiale ma agirò sulle portate fino a trovare la minima che mantenga la temperatura desiderata.
Grazie ancora.
Buonasera a tutti. Sono alla ricerca di alcuni chiarimenti circa impianti di riscaldamento a pavimento in uno stabile anni ’60: sto per acquistare un appartamento allo stato originario e mi chiedo se sia il caso di ristrutturare anche l’impianto perché credo che 50 anni siano forse il limite di durata, cosa mi consigliate? Vale la pena intervenire sui pavimenti senza toccare il riscaldamento (che oltretutto a mio avviso è troppo caldo essendo io abituata al riscaldamento autonomo tradizionale), oppure rischio di dover disfare tutto tra 5 anni perché l’impianto va rifatto? Inoltre leggendo qua e là mi sembra di capire che anche se decidessi di intervenire ristrutturando l’impianto, le nuove tecnologie (sia dell’impianto in sé che delle eventuali termo-valvole) non siano compatibili con le caldaie di vecchia generazione: è vero? Quindi ho alternative che non ho considerato? Accetto volentieri consigli autorevoli. Grazie.
A casa (tre livelli per 150mq) dispongo di un impianto di riscaldamento a pavimento. La casa ha 8 anni e recentemente mi è andata in blocco la caldaia. Ho chiamato pertanto la ditta specializzata, risolvendomi il problema. Tuttavia mi è stato detto che devo fare un intervento di manutenzione e pulizia dell’impianto, per il deposito di alghe che “frenano” la funzionalità dell’impianto. Mi hanno fatto avere un preventivo di 385€. Mi chiedo se non sia troppo costoso e se l’intervento sia strettamente necessario…
I sistemi di impianti radianti a pavimento moderni, sono compatibili, dotandoli di adeguato scambiatore per ridurre la temperatura di mandata, con un impianto condominiale che il comune richiede non sia acceso per più di 14 ore al giorno? Come rendere compatibile un impianto di questo tipo, lasciando liberi gli altri condomini di disporre dei radiatori, dunque con un impianto “tradizionale” con caldaia a condensazione?
Vorrei fare una domanda a voi più esperti.
E’ possibile installareal piano terra la cassetta di diramazione dei tubi che vanno al primo piano?
Praticamente vorrei mettere tutte e due le cassette vicine al piano terra…
Grazie.
Buongiorno volevo chiedere gentilmente un’informazione. Ho visto sul sito che si parla del riscaldamento a pavimento e la foto dei collettori che sono uguali ai miei che sono della buderus. Io ho una camera a nord che è sempre più fredda volevo provare a bilanciare l’impianto sul collettore di ritorno dove tu hai le testine termostatiche più due detentori con tappino blu. Io ho tutti i tappini blu perchè non ho le testine, invece sul collettore di mandata che è uguale al mio ci sono dei livelli con numeri da 1 a 5. Intorno c’è una ghiera bianca che gira, ma gira a vuoto. Volevo chiedere e da li che devo regolare, ma come faccio? Sotto c’è un dado ottonato ma non penso sia quello altrimenti si smonta tutto. Spero che riusciate ad aiutarmi perchè non chiedo agli idraulici in quanto sono dei fenomeni che addirittura mi hanno collegato la caldaia dove ho il gpl con gli ugelli del metano, non ti dico che casino, quindi non sanno nemmeno da dove iniziare a bilanciare un impianto. Grazie mille.
Buongiorno, complimenti per il sito e per le risposte professionali.
Io sono alle prese con reverse engineering dell’impianto a pavimento ereditato nella mia casa.
L’impianto e’ molto semplice (2 zone – giorno e notte). 2 Collettori Uponor. Caldaia a condensazione paradigma. Ho gia’ ricostruito la mappatura delle stanze. e ho la lunghezza delle linee. Superficie di circa 230 metri quadrati su unico piano terra.
Sono pero’ nella fase di regolazione temperatura di mandata e pressione dei flussometri. Vorrei avere piu’ caldo nella zona giorno.
Ha per caso un template di un excel dove posso iniziare a mettere qualche infomazione per cercare di modellare il progetto iniziale?