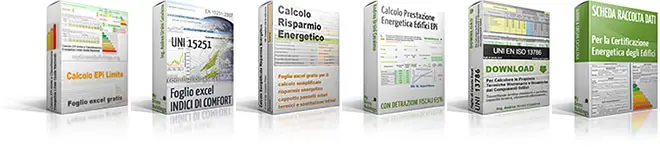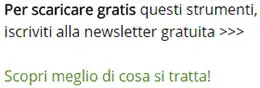Gli indici di comfort termico e i metodi per calcolarli sono stati recentemente raggruppati in una nuova norma tecnica: EN 15251:2007 (Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics).

Photo credit: splityarn
Secondo la norma tecnica EN 15251:2007, le temperature di comfort accettabili dipendono dal tipo di sistema usato per fornire il comfort termico.
Se, ad esempio, il raffrescamento è fornito mediante un sistema attivo (meccanicamente), allora le temperature interne devono rispettare quelle definite dal modello di Fanger (UNI 7730).
Se invece il comfort termico è mantenuto mediante strategie di raffrescamento passivo (senza apparecchi meccanici), allora il limite di temperatura superiore e inferiore è imposto dal modello di Comfort Adattivo.
Il Modello di Fanger

Photo credit: adamneilward
Il Modello di Fanger vede le persone come soggetti passivi di scambio termico, all’interno di ambienti chiusi verso l’esterno e climatizzati. Tale modello prescrive temperature ottimali pressoché costanti, a parità dei valori di sei variabili indipendenti:
- temperatura (Ta)
- umidità relativa (Ur)
- velocità dell’aria (v)
- temperatura media radiante (Tm.rad) (sinteticamente, è la media delle temperature superficiali di pareti, solai, finestre e porte di una stanza)
- isolamento termico del vestiario (clo)
- livello di attività metabolica (met)
Gli indici di comfort secondo il modello di Fanger sono il PMV (Predicted mean vote o Voto Medio Previsto) e il PPD (esprime la percentuale di persone insoddisfatte in un determinato ambiente). Il PMV esprime la sensazione media di comfort degli occupanti di una stanza.
Il PMV è funzione quindi delle sei variabili di cui sopra:
PMV = f(Ta, Ur, v, Tm.rad, clo, met)
In funzione del tipo di edificio, occorre rispettare diversi limiti di PMV, che possono variare da -0,2 < PMV < 0,2 a -0,7 < PMV < 0,7.
Negli ultimi anni molti ricercatori hanno iniziato a mettere in dubbio la validità di questo tipo di impostazione, che non tiene conto di importanti fattori come quelli climatici, culturali, sociali e contestuali, ed hanno introdotto il concetto di adattamento, che spiega come il contesto e la storia termica di ciascun soggetto possano modificare le aspettative e le preferenze termiche degli occupanti.
Il Modello di Comfort Adattivo

Photo credit: jeffwerner
Nel Modello di comfort adattivo l’occupante di un edificio non è più semplicemente inteso come un soggetto passivo, così come appariva nel modello statico (Fanger PMV), ma come un agente attivo che interagisce a tutti i livelli con l’ambiente in cui soggiorna.
Il modello di comfort Adattivo propone una correlazione tra la temperatura di comfort per gli occupanti (T operativa) di un edificio e la temperatura dell’aria esterna (Tem).
Il modello adattivo introduce quindi algoritmi di controllo e di risposta che permettono di migliorare il livello di comfort termico degli occupanti e di ridurre il consumo di energia.
Ecco la correlazione secondo la EN 15251:2007:
Top = 0,33*Tem+18,8 (Temperatura operativa ottimale giornaliera/oraria)
Si ottiene una fascia di comfort per un periodo desiderato (ad esempio la stagione estiva, in assenza di climatizzazione meccanica), calcolata sommando e sottraendo alcuni gradi °C (in funzione del tipo di edificio) dalla curva della temperatura operativa ottimale (nel prossimo articolo ulteriori approfondimenti sulla valutazione del comfort adattivo).
Alla base del modello di comfort adattivo c’è la convinzione che il soggetto, consciamente o inconsciamente, svolge un ruolo attivo nella creazione delle condizioni termiche che preferisce e che, per raggiungere più facilmente la soddisfazione nei confronti del microclima, attua un processo di adattamento, definito come quel processo di graduale diminuzione delle reazioni individuali agli stimoli ambientali.
Si distinguono tre tipi di adattamento:
- comportamentale: complesso dei cambiamenti che una persona mette in atto, consciamente o no, per modificare i parametri che regolano il bilancio termico del corpo; può essere suddiviso in personale, tecnologico e culturale
- fisiologico: l’esposizione prolungata a date condizioni riduce lo stress; nelle condizioni tipiche degli ambienti moderati questo tipo di adattamento ha un’influenza trascurabile sulla percezione del comfort
- psicologico: le esperienze pregresse e le aspettative modificano la percezione degli stimoli sensoriali e la reazione ad essi.
Tra i tre meccanismi di adattamento quello comportamentale fornisce alle persone un ruolo attivo nel mantenimento del proprio comfort, proprio perché direttamente legato al bilancio termico del corpo umano.
Il modello adattivo, generalmente, definisce temperature di comfort maggiori e più flessibili rispetto al modello di Fanger. Spesso la temperatura di comfort adattiva ottimale può essere raggiunta utilizzando strategie di raffrescamento passivo, come l’ombreggiamento delle finestre e la ventilazione notturna. In questi casi, il fabbisogno di raffrescamento si riduce praticamente a zero, e non è necessario (o quasi) un raffrescamento meccanico.
Approfondimento sul comfort termico interno, modello di Fanger e Adattivo (Scarica PDF).
Diagramma Bioclimatico di Givoni
Photo credit: Ing. Andrea Ursini Casalena
Il diagramma bioclimatico di Milne-Givoni è adatto per prevedere le condizioni di comfort termico-igrometrico interno di un edificio in base alle condizioni climatiche esterne prevalenti.
Givoni ha basato il suo studio sul rapporto lineare che intercorre fra l’ampiezza di temperatura e la pressione di vapore dell’aria esterna in varie regioni. Sul diagramma psicrometrico, sono indicati sovrapposti i limiti delle strategie di raffrescamento e riscaldamento passive.
Le strategie considerate includono:
- massa termica
- raffrescamento evaporativo
- ventilazione naturale diurna e notturna
- raffrescamento e riscaldamento passivo
Il diagramma bioclimatico di Givoni è uno strumento di progetto, un modo semplice per scegliere le strategie progettuali perseguibili per un edificio in funzione della zona climatica di appartenenza.
Sovrapponendo sul diagramma bioclimatico di Givoni i punti caratteristici di una particolare zona climatica, derivanti dall’intersezione della temperatura dell’aria esterna e l’umidità specifica dell’aria, si ha una visione d’insieme delle condizioni climatiche. La concentrazione più o meno densa di tali punti su aree specifiche del grafico permette di scegliere le strategie progettuali da applicare all’edificio.
Sul prossimo articolo ti farò vedere delle applicazioni pratiche.
Approfondimenti
- Sulla valutazione del comfort termico: sviluppi normativi e problemi aperti
- Il benessere termoigrometrico: elementi di climatizzazione radiante
- L’abbigliamento e il comfort termico: quale relazione?
- Elementi di bioenergetica: il comfort termico
- Il Benessere Termico e i modelli di comfort