L’illuminazione naturale costituisce una risorsa importante per il concepimento di edifici energeticamente sostenibili e qualitativamente confortevoli. Come calcolare la quantità di luce naturale negli edifici? Con quali software? E’ sufficiente la verifica della superficie finestrata pari a 1/8 del pavimento per avere una corretta illuminazione negli ambienti interni? Cosa dice effettivamente la normativa?
Ecco la prima parte dell’approfondimento, dal fattore medio di luce diurna agli adempimenti normativi.
Nella progettazione di ambienti destinati allo svolgimento di attività da parte dell’uomo è necessario porre attenzione al rapporto che si crea tra interno ed esterno, anche sotto l’aspetto della luce naturale. Un accurato dimensionamento e posizionamento delle aperture trasparenti comporta notevoli vantaggi nella fruizione dello spazio abitato.
E’ dimostrato che la luce naturale ha numerosi effetti positivi sull’uomo sia di tipo fisiologico che psicologico, per cui migliora il livello di attenzione e produttività, riduce il rischio di problemi alla vista, affaticamento dell’occhio, stanchezza precoce e cefalee, favorisce l’equilibrio del metabolismo e ha anche un’azione battericida nell’ambiente.
Quando si parla di “comfort abitativo” oltre a quello termo-igrometrico, acustico e olfattivo, bisogna sempre tenere in considerazione anche il comfort visivo, che a sua volta viene raggiunto attraverso una progettazione integrata tra illuminazione naturale e artificiale. In effetti la luce naturale è caratterizzata da una grande componente di incertezza e variabilità che dipende dalle condizioni meteorologiche, dall’ora del giorno, dal periodo dell’anno, dalla posizione geografica, dall’orientamento dell’edificio e da eventuali ostruzioni esterne, per cui per garantire un adeguato livello di comfort visivo in ogni momento è necessario fare ricorso alla luce artificiale.
Un’adeguata illuminazione naturale contribuisce in maniera significativa al risparmio energetico negli edifici in quanto può fornire l’illuminamento richiesto per l’80-90% delle ore di luce diurna, permettendo il risparmio di una considerevole quantità di energia che altrimenti sarebbe necessaria per l’illuminazione artificiale.
La direttiva europea 2002/91/CE sulla certificazione energetica negli edifici prevede, oltre al calcolo dei consumi legati al riscaldamento e raffrescamento, anche quello relativo ai consumi di elettricità ai fini dell’illuminazione. Essa ha dato impulso all’emanazione della norma europea EN 15193 del 2007, che introduce un indice (il LENI – Lighting Energy Numeric Indicator) per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici relative all’illuminazione.
Gli edifici del futuro saranno sempre più termicamente efficienti per cui ne consegue che l’illuminazione condizionerà fortemente i consumi energetici complessivi, specie per gli edifici destinati a uffici, laboratori e terziario in generale in cui il livello di illuminamento imposto dalle normative è elevato.
Inoltre non bisogna dimenticare che la radiazione solare (costituita per circa il 50% da radiazioni visibili) può essere fonte di un notevole guadagno termico per gli ambienti. Se pensiamo a un soggiorno con un’ampia vetrata a sud, all’interno di una casa ben isolata (diciamo una casa quasi passiva), in una giornata invernale di sole, grazie all’effetto serra che si crea, probabilmente non avremo nemmeno bisogno di accendere i riscaldamenti o comunque, il consumo energetico per il riscaldamento del soggiorno sarà molto vicino allo zero.
Bisogna però guardare anche l’altra faccia della medaglia. Ampie aperture trasparenti comportano maggiori dispersioni termiche nei periodi freddi, ingresso di energia solare e calore indesiderati nei giorni caldi estivi e in alcuni casi discomfort visivo a causa di un eccessivo livello di luce in ingresso e quindi fenomeni di abbagliamento.
Anche in questo caso la verità sta nel mezzo. Per cui si può non rinunciare ad una risorsa rinnovabile e gratuita come quella della luce del sole utilizzando alcuni accorgimenti.
Ad esempio sono sempre più diffuse le schermature solari mobili (rientrano nel nuovo Conto Energia Termico!) che in base alla necessità e al periodo dell’anno ombreggiano le vetrate oppure lasciano passare la radiazione solare, magari comandate da sistemi di controllo automatizzati che regolano anche l’accensione delle luci artificiali nel caso in cui quella naturale non sia sufficiente.
Si può avere un’ottimizzazione del sistema involucro-impianto grazie alla domotica, riuscendo a minimizzare i consumi energetici complessivi senza rinunciare al comfort visivo.
Cosa Dice la Normativa Italiana Riguardo l’Illuminazione Naturale degli Ambienti?

Il quadro legislativo nazionale è piuttosto carente e soprattutto poco aggiornato visto che è fermo al 1975. I documenti legislativi e tecnici che danno indicazioni in merito sono i seguenti:
- D.P.R. n. 303 del 19/3/56 – “Norme generali per l’igiene del lavoro”
- Circ. Min. LL. PP. n. 3151 del 22/5/67 – “Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione delle costruzioni edilizie”
- Circ. Min. LL. PP. n. 13011 del 22/12/74 – “Requisiti fisico-tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. Proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione”
- D.M. 5/7/75 – “Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20/6/1896 relative altezza minima dei locali ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione”
- D.M. 18/12/75 – “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.
Il D.M. 5 luglio 1975 è una pietra miliare nel settore della progettazione di edifici residenziali, riguarda le dimensioni minime degli ambienti e in particolare per la questione della luce naturale all’art. 5 dispone quanto segue:
“Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso. Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.”
Un’errata interpretazione dell’articolo ha diffuso l’opinione che la proporzione di 1/8 tra finestre e pavimento sia sufficiente a garantire un illuminamento adeguato della stanza. Dal testo invece appare chiaro che vanno effettuate entrambe le verifiche. In effetti gli studi sull’illuminotecnica confermano che il Fattore Medio di Luce Diurna (FLDm) dipende da numerosi fattori e non solamente dall’entità della superficie vetrata o dal rapporto tra essa e la superficie della stanza. Molto probabilmente la maggior parte dei tecnici dal ’75 ad oggi ha svolto solo la verifica del “1/8” nelle varie stanze tralasciando la questione del 2% anche a causa delle difficoltà oggettive che si riscontravano nel determinare questo parametro.
Gli altri decreti e circolari indicati sopra riguardano principalmente l’edilizia pubblica (scuole e ospedali) e forniscono anch’essi dei valori minimi di FLDm da rispettare nei vari ambienti. Questo valore sarà tanto più alto quanto più il compito da svolgere in un determinato locale è di lunga durata e richiede maggiore sforzo visivo, per cui è evidente che ad esempio il FLDm di un’aula scolastica dovrà essere maggiore di quello di una sala da pranzo che a sua volta sarà maggiore del FLDm di un bagno.
Per completare questo breve excursus normativo si riporta di seguito una tabella che riassume i valori minimi di legge per le differenti destinazioni d’uso degli ambienti:
Cos’è il Fattore Medio di Luce Diurna (FLDm)?

Prima di dare una definizione occorre introdurre un’altra grandezza fisica dell’illuminotecnica: l’Illuminamento.
L’Illuminamento (E) è il rapporto tra il flusso luminoso ricevuto da una superficie e l’area della superficie stessa. In altre parole indica la quantità di luce che colpisce un’unità di superficie e si misura in Lux [lx] = [lm / m²] (lm = lumen).
A questo punto definiamo il Fattore di Luce Diurna (FLD) come il rapporto tra l’illuminamento (Eint) che si realizza su di una superficie orizzontale posta all’interno dell’ambiente considerato grazie alla luce proveniente dalla volta celeste (escludendo la radiazione diretta proveniente dal sole), e quello che contemporaneamente si ha su di una superficie orizzontale posta all’esterno senza alcuna ostruzione (Eest).
In base a tale definizione il Fattore di Luce Diurna può essere calcolato con la relazione FLD = Eint/Eest, è una grandezza adimensionale e generalmente viene espressa in percentuale (es. FLD = 2%).
Quando si valuta il livello di illuminazione naturale di un ambiente, salvo casi particolari, non è necessario conoscere il FLD per ogni punto dello spazio, ma può risultare più pratico ed efficace avere un unico valore numerico che rappresenti la media di tutti i FLD nei vari punti della stanza, ovvero il Fattore Medio di Luce Diurna (FLDm). Anche perché poi le verifiche di legge vanno effettuate confrontando proprio il FLDm dell’intera stanza con quello minimo imposto dalla normativa. Per essere ancora più precisi bisogna specificare che il valore limite di legge è riferito ad un solo piano e non all’intero spazio tridimensionale della stanza.
Per calcolare il FLDm si sceglie quindi un piano di lavoro, ovvero un piano di riferimento parallelo al pavimento e posto ad un’altezza da questo ad esempio di 90 cm. Per ogni punto del piano si calcola il FLD e quindi si fa una media fra tutti i punti per ottenere il FLDm relativo a quel piano specifico. Cambiando l’altezza del piano in genere cambiano i valori, quindi può capitare che il FLDm misurato all’altezza del pavimento sia totalmente diverso da quello misurato al soffitto. Per questo motivo è indispensabile scegliere il piano di calcolo in base al tipo di attività che si svolge nell’ambiente.
Da Cosa Dipende il Fattore Medio di Luce Diurna di un Ambiente?

All’interno di un ambiente chiuso l’illuminamento naturale nei diversi punti è costituito da tre componenti: l’apporto di luce proveniente dalle sorgenti primarie esterne (il cielo), l’apporto di luce dovuto alle riflessioni delle superfici di eventuali ostruzioni urbane esterne, l’apporto di luce dovuto alle riflessioni multiple che si verificano all’interno dell’ambiente. Per cui in sintesi possiamo affermare che il FLDm dipende dai seguenti parametri:
- dimensione, forma e posizione delle aperture finestrate
- coefficiente di trasmissione nel visibile del materiale trasparente che costituisce le finestre
- area dei diversi elementi che costituiscono l’involucro e che sono presenti all’interno del locale (pareti, pavimenti, soffitti, arredi, ecc.)
- coefficiente di riflessione nel visibile delle superfici dei vari elementi presenti all’interno del locale
- presenza di ostruzioni di qualsiasi genere, esterne o interne, che limitino la vista della volta celeste
- stato di manutenzione delle superfici vetrate e delle superfici interne
- altezza del piano di lavoro scelto.
Nella valutazione delle condizioni di illuminazione naturale interna si considera il caso più sfavorevole, che si verifica in assenza di radiazione solare diretta, caratterizzata invece da una forte direzionalità in funzione della posizione del sole.
Posto il cielo coperto come condizione ottimale di valutazione, il rapporto tra illuminamento interno ed esterno deve essere costante, per cui il FLDm non dipende dall’ora del giorno, dal periodo dell’anno nè dall’orientamento del locale.
Come si Calcola il Fattore Medio di Luce Diurna (FLDm)?

Esistono diversi metodi di calcolo che differiscono tra loro per semplicità d’uso e soprattutto per l’affidabilità nel trattare situazioni geometricamente complesse.
Una distinzione di base può essere fatta tra metodi che valutano globalmente le tre componenti e metodi che invece valutano singolarmente ciascuna di esse. Le tre componenti possono essere stimate con software specifici oppure con differenti metodi grafici, tabulari e analitici.
Un metodo di calcolo molto diffuso è rappresentato dalla seguente formula:
Il calcolo risulta estremamente semplice mentre può non essere altrettanto scontato il procedimento di individuazione dei valori numerici da inserire, che richiede a sua volta l’utilizzo di tabelle e grafici.
Fortunatamente al giorno d’oggi esistono numerosi software, anche gratuiti, che permettono di calcolare il FLDm per ogni ambiente in maniera molto semplice e rapida.
Nella seconda parte di questo articolo illustreremo passo passo come utilizzare un software gratuito (Velux Daylight Visualizer) per poter calcolare il Fattore Medio di Luce Diurna degli ambienti interni e quindi essere in grado di verificarne i parametri minimi imposti dalla legislazione.
A cura di Ing. Alessandro Marchegiani
Photo credit: seier, pixelasso, Velux


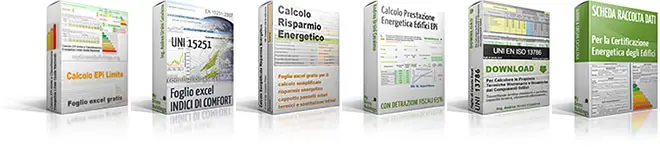
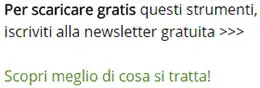



Dove posso trovare la seconda parte di questo articolo relativa all’utilizzo di velux?
Grazie
Ciao Cristina, l’articolo sarà presto pubblicato su MyGreenBuildings.org.
Se sei iscritta alla newsletter di MyGreenBuildings, sarai avvisata tempestivamente.
A presto!
Ciao,
sai se è uscita la seconda parte con il foglio di calcolo per EpIll?
Grazie
Saluti
Sonia
Ciao non sono al corrente di fogli excel per il calcolo dell’EPill, ma cercherò di realizzarne uno appena possibile.
Buona giornata.
Ciao ho pubblicato la seconda parte dell’articolo con il tutorial su Velux Daylight Visualizer per il calcolo del fattore medio di luce diurna.