Alcuni operatori del mercato edilizio sostengono che se gli edifici non respirano o se non realizziamo muri che respirano, possiamo incorrere, molto probabilmente, in problemi di umidità negli ambienti interni e pregiudicarne la qualità dell’aria.
La domanda però è questa: ma i muri respirano? E se anche fosse vero, e purtroppo spesso avviene (leggi sotto perchè), sarebbe un vantaggio?
Cerchiamo insieme di fare chiarezza.

Che si tratti di abitazioni, scuole, uffici, fabbriche o centri commerciali, le persone trascorrono fino al 90% della loro vita negli edifici. Garantire un clima interno sano e confortevole negli edifici è quindi di fondamentale importanza.
Allo stesso tempo, sia i nuovi edifici che quelli esistenti devono soddisfare livelli di efficienza energetica sempre più elevati che richiedono strati di isolamento termico più spessi e un elevato grado di tenuta all’aria dell’involucro edilizio per evitare perdite termiche da flussi d’aria incontrollati.
Alcuni operatori del mercato sostengono che le strutture edilizie con una buona tenuta all’aria causerebbero climi interni malsani. Sembrerebbe che per mantenere livelli di umidità interna accettabili e quindi una buona salubrità dell’aria, occorra necessariamente utilizzare materiali “traspiranti” o che “respirino”.
Purtroppo, però, i termini “respira” o “traspira” sono confusi con fenomeni fisici diversi.
In fisica tecnica delle costruzioni di solito non si usano questi termini quando si vuole descrivere i seguenti fenomeni fisici:
- condensa del vapore acqueo sulle superfici interne
- effetto tampone di umidità all’interno di elementi edilizi (moisture buffering)
- diffusione del vapore acqueo attraverso elementi edilizi
- trasporto dell’umidità mediante infiltrazioni d’aria, ventilazione naturale o meccanica
Comfort Interno e Livelli di Umidità Relativa
Il livello di umidità interna negli edifici dipende da diversi fattori come le condizioni climatiche, le fonti interne di umidità, il tasso orario di ricambio d’aria, il volume degli ambienti e le possibili capacità di assorbimento dell’umidità dei materiali da costruzione a contatto con l’aria interna.

Il livello di umidità dell’aria interna può presentare ampie variazioni giornaliere a seconda dei carichi termici e di umidità causati dall’occupazione degli spazi.
La temperatura e l’umidità dell’aria interna sono alcuni dei fattori più importanti che incidono sul comfort interno, sia sul comfort termico che sulla qualità dell’aria percepita. Condizioni di umidità particolarmente elevate possono influire negativamente sul benessere termo-igrometrico.
Leggi anche l’importanza di valutare il comfort abitativo
Ci sono diversi metodi per ridurre i picchi di umidità durante l’occupazione degli ambienti e, quindi, migliorare il comfort termico e l’accettabilità delle condizioni interne.
VTT Expert Services ha studiato come ciò sarebbe possibile utilizzando la capacità di assorbimento dell’umidità delle strutture dell’edificio.
Cambridge Architectural Research ha invece mostrato l’importanza del ricambio d’aria per ventilazione naturale rispetto al trasporto di umidità per diffusione attraverso gli elementi di costruzione.
Moisture Buffering dei Materiali da Costruzione (Effetto Tampone)
Il concetto di effetto tampone dell’umidità (moisture buffering) delle strutture edilizie può essere espresso attraverso l’interazione igrotermica tra le strutture degli edifici e l’aria interna.
Queste interazioni possono contribuire al comfort e alla qualità dell’aria interna riducendo i picchi temporanei di umidità. Tali picchi di umidità possono ad esempio verificarsi nelle camere da letto durante la notte o nei bagni o in cucina, ma non solo.
Al fine di migliorare il comfort termico e la qualità dell’aria interna mediante metodi passivi è possibile quantificare il valore di accumulo dell’umidità dei materiali da costruzione. La figura sotto mostra alcuni materiali con la loro capacità di assorbimento dell’umidità (moisture buffering).

VTT Expert Services ha verificato con uno studio numerico come gli strati di isolamento termico possano contribuire all’effetto tampone dell’umidità.
L’obiettivo era mostrare quanta umidità potesse essere immagazzinata nello strato di isolamento termico posizionato subito dietro al primo strato di materiale a contatto con l’aria interna dell’ambiente. La figura sotto rappresenta le diverse stratigrafie analizzate.

Queste simulazioni mostrano che, se l’effetto tampone del materiale a contatto con l’aria interna è elevato, la capacità di accumulo di umidità dello strato di isolamento termico retrostante è irrilevante.
Lo studio mostra che la maggior parte dell’umidità è immagazzinata nel pannello in fibra di legno poroso (Pwfb) e che non vi è alcuna reale differenza tra un materiale isolante a celle aperte come la fibra di cellulosa o un pannello PU a celle chiuse.

Quando si utilizzano materiali superficiali con bassa capacità di accumulo di vapore acqueo (ad esempio pannelli di cartongesso), si nota un contributo maggiore di accumulo di vapore negli strati di isolamento termico. Sebbene l’effetto tampone del PU sia inferiore, la capacità di accumulo di vapore acqueo complessiva dell’elemento parete è pressoché la stessa.

Il principale vantaggio della capacità di assorbimento dell’umidità delle strutture è la riduzione dei valori di picco dell’umidità interna durante i periodi di occupazione.
Per sfruttare in modo efficiente questa caratteristica, il materiale della superficie interna deve avere un’elevata capacità di effetto tampone. In queste condizioni, le proprietà di accumulo dell’umidità dello strato di isolamento termico non saranno rilevanti.
Trasporto dell’Umidità per Diffusione e per Ventilazione
Nello studio citato si è quindi scoperto che l’effetto di moisture buffering è rilevante per attenuare le variazioni giornaliere di umidità.
Tuttavia, quando sono state confrontate le strutture ad alto assorbimento igroscopico con quelle a basso assorbimento o meglio con presenza di barriere o freni al vapore, i valori di umidità relativa negli ambienti nel medio e lungo periodo (settimane o mesi) erano quasi gli stessi.
Il ricambio d’aria mediante ventilazione naturale è evidentemente una strategia molto importante per la regolazione dell’umidità interna. Questo è stato uno degli studi di Cambridge Architectural Research.
Il passaggio del vapore acqueo dagli ambienti interni a quelli esterni avviene attraverso questi due meccanismi principali:
- diffusione del vapore acqueo attraverso l’involucro edilizio (tetto, parete, pavimento)
- ricambio d’aria per ventilazione naturale, ventilazione meccanica, infiltrazioni.
Spesso molti operatori del mercato edilizio affermano che se l’edificio non “respira” o se i materiali delle pareti non “respirano”, specialmente nelle ristrutturazioni di edifici esistenti, si incorre in problemi di umidità negli ambienti. Oppure si possono avere problemi di condensa superficiale sulle pareti e quindi la nascita di muffe con tutte le conseguenze che questo comporta.
Al fine di verificare queste affermazioni, Cambridge Architectural Research Ltd. (CAR) ha condotto uno studio sul trasferimento dell’umidità negli edifici.
In particolare hanno messo a confronto la diffusione del vapore acqueo attraverso le strutture opache con quello che può essere trasportato dal ricambio d’aria mediante ventilazione.
Lo studio ha riguardato tre pareti con diversa resistenza al passaggio del vapore acqueo ipotizzando un tasso orario di ricambio d’aria pari a 0,5. La normativa italiana, per esempio, impone dei ricambi d’aria minimi a seconda della destinazione d’uso dell’edificio.

I calcoli dimostrano che la diffusione del vapore acqueo attraverso le cosiddette strutture edilizie “traspiranti”, non contribuisce in modo significativo alla velocità di smaltimento del vapore acqueo.
La diffusione del vapore acqueo attraverso le strutture opache, in questo caso, nel migliore dei casi corrisponde al 5% del vapore acqueo presente all’interno degli ambienti.
Pertanto per mantenere dei livelli accettabili di umidità relativa interna e quindi una buona qualità dell’aria interna, è necessario un ricambio d’aria per ventilazione (naturale o meccanica). In questo caso il trasporto di umidità corrisponde a ben il 95% di quella presente nell’ambiente.

Ipotizzando che i muri possano respirare, ovvero che permettano il passaggio di aria e quindi di consistente vapore acqueo, ci sarebbero dei seri problemi dovuti alla condensazione interstiziale.
Questo è il caso di un involucro edilizio opaco con bassa tenuta all’aria, non realizzato a regola d’arte. Pensiamo agli edifici in legno, edifici in paglia, edifici in laterizio, progettati e costruiti male.
I dettagli fanno la differenza.

Il problema della condensa interstiziale è potenzialmente molto dannoso, per esempio, per i materiali isolanti. Il contenuto di umidità all’interno di tali materiali, oltre ad attivare processi di deterioramento, causa un decadimento delle proprietà isolanti. Il vapore d’acqua va a riempire lo spazio occupato dall’aria, unico elemento che permette ai materiali di isolare termicamente.

Credit:
A Survey of the Breathable Building Structure Concept: Effects of Insulation Materials, VTT Expert Services Ltd., 2011
Moisture transfer and the significance of breathability in buildings, Cambridge, Architectural Research Ltd. (CAR) – 2008
Approfondimenti


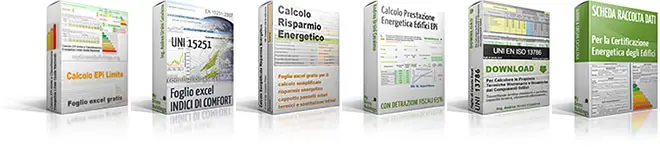
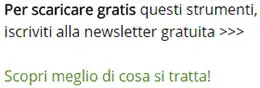






Ciao Andrea… veramente interessante l’articolo.
Guarda caso, ieri ho tenuto un webinar (Azero tour) dove ho trattato il tema della coibentazione termica realizzata all’interno. Nel caso specifico si trattava di casa mia e pertanto ho cercato di sperimentare un po’ per poter verificare sulla propria pelle gli effetti di tali scelte, monitorando poi il tutto quotidianamente. Per quanto concerne la questione delle pareti che respirano…è proprio un’affermazione “commerciale” in quanto la migrazione per diffusione sarà intorno al 3%. Mettici sopra un cappotto in EPS e la diffusione scenderà al 1.5 – 2%. Sicuramente meno di prima ma ti manca sempre quel 97 – 98% che devi far uscire per ventilazione.
Nella riqualificazione di cui sopra ho utilizzato dei pannelli isolanti in idrato di silicato di calcio, posati all’interno e finiti direttamente con un intonaco leggero. Il sistema così creato è molto aperto alla diffusione e pertanto a rischio condensa interstiziale. Per ovviare a tale problema ho contenuto lo spessore della coibentazione a 6 cm (non volevo inoltre esagerare per non perdere troppo spazio interno) affiancando il tutto ad una VMC di tipo entalpico che mantiene l’umidità relativa intorno al 40% +- 5%. A dire il verò il montaggio della VMC è avvenuto circa 2 mesi fa così ho potuto testare il comportamento igrometrico anche in assenza di un impianto di ventilazione. L’umidità relativa senza VMC variava tra il 50 ed il 60% circa, ventilando con l’apertura delle finestre dalle 2 alle 3 volte al giorno. Grazie alla coibentazione in schiuma minerale i picchi sono stati sempre molto contenuti (max + 7-8% di U.R. al mattino in stanza) ed confort alto. Se ti serve qualche altro dato…Fammi sapere. Ciao!
Ciao Igor, grazie a te per la condivisione. Se hai il link alla registrazione del webinar, puoi anche postarla qui a beneficio di tutti i lettori.
Ciao a presto!
Sono perfettamente d’accordo con quanto esposto. Perché l’unico elemento che evita la formazione della condensa è la ventilazione, sia naturale che meccanica. Indubbiamente la ventilazione meccanica con recupero di calore è quella ottimale per il contenimento energetico, ma in quei casi dove – anche per motivi economici – non è possibile installare un sistema meccanico va benissimo quello naturale.
Ottimo, ne ero già convinto. La tua analisi è molto interessante e condotta come sempre in modo scientifico e esaustivo. Io ho previsto (partendo dall’interno) doppia lastra di cartongesso e barriera al vapore + isolante, il resto lo lascio alla VMC. Complimenti!
Ho invece ancora dei dubbi sul solaio areato ovvero sui pro e contro. Nel mio caso ho cercato di isolare termicamente il pavimento e ho previsto molte prese d’aria (che potrei tuttavia in parte chiudere) ma con i bilanci energetici fatti a suo tempo con Termus (ma che ho rifatto anche con fogli di calcolo faidamé per poter toccare con mano i vari risultati) ho trovato un po’ empirica la normativa. Hai magari approfondito l’argomento in qualche post dedicato? Grazie
Ciao Alberto, grazie per l’interesse.
Se avessi utilizzato dei pannelli in terra cruda o materiali con un elevato effetto tampone, saresti riuscito probabilmente a gestire meglio i picchi di umidità interni.
Per quanto riguarda i solai, vedremo di parlarne in un prossimo approfondimento.
Per chi pensa che installare un cappotto esterno poco “traspirante” possa causare problemi di condensa superficiale sul lato interno della parete.
Il problema della condensa superficiale interna dipende quasi esclusivamente da due fattori:
1. una temperatura superficiale troppo bassa
2. un livello di umidità relativa nell’ambiente troppo alto
Il miglior modo per risolvere il primo punto, ovvero di alzare la temperatura superficiale interna della parete, è quello di aumentare l’isolamento termico. Il cappotto termico esterno, pertanto, è sempre la soluzione migliore e non è mai la causa del problema.
Se il problema persiste, significa che: o l’isolamento termico installato non è sufficiente oppure il livello di umidità interna è troppo alta.
Vanno fatte delle verifiche termo-igrometriche, anche con analisi agli elementi finiti.
Ciao.
Grazie Andrea per il video, semplice e chiaro, che ho inviato volentieri ad alcuni colleghi che mi hanno tempestato di domande sulle muffe che si creano negli ambienti quando non vengono “gestiti” in modo appropriato: spesso in tribunale capitano consulenti che non distinguono “bene” (per unsare un eufemismo spinto) il fenomeno di condensa superficiale da quello di infiltrazione e si creano delle giostre incredibili (mi viene da piangere…) …
In definitiva ti ringrazio per aver chiarito ed accennato almeno per sommi capi il problema della gestione corretta degli ambienti.
“sei il mio idolo” ;)
Ciao Massimo, troppo gentile :-)
Buongiorno
Un vecchio collega mi ha sempre detto che le case sono come l’uomo “è vero che la pelle umana traspira, ma se gli tappi i buchi (naso, bocca e c….) non respira più e muore”
Ciao Andrea, finalmente un articolo con studi documentati sulla quota di vapore che può essere smaltita attraverso gli elementi dell’involucro, per quanto traspiranti. Condivido soprattutto il tuo ultimo post. Mi sfugge un po’ il discorso dell’effetto tampone, su quali materiali siano più idonei per ridurre i picchi di umidità, in relazione ad altre caratteristiche (in particolare alla capacità di isolamento termico, ma anche strutturali, spessori necessari, ecc.), nonché al costo… ovvero, partendo dal presupposto che è necessario garantire la ventilazione dei locali, se sia conveniente dal punto di vista tecnico-economico il loro impiego per contenere i picchi.
Considerazione: è sicuramente vero che l’aria non corre attraverso le strutture dell’involucro, per quanto traspiranti, ma nei vecchi edifici i serramenti e l’involucro sono talmente scadenti che le infiltrazioni bastano a garantire un ricambio magari basso ma continuo e quindi la gente è poco avvezza ad aprire le finestre e difficilmente cambierà le proprie abitudini; anzi, dopo un intervento di riqualificazione si aspetterà di dover aprirle ancora meno. Negli interventi di riqualificazione – salvo registrare ogni conversazione o fare preventivamente una scrittura informativa controfirmata da esibire quando ti accuseranno “se me l’avessi detto”, dopo che gliel’hai detto e ti hanno guardato come se fossi un marziano – è sempre meglio prevedere un sistema di ventilazione di qualche tipo, fossero anche due buchi nel muro…
Ciao Gabriele, per buchi appunto, in un edificio, si intende il ricambio d’aria per infiltrazione (quello a finestre chiuse per intenderci attraverso gli “spifferi”), per ventilazione naturale e meccanica. Sicuramente non si intende passaggio di aria attraverso l’involucro opaco, sarebbe un bel problema se fosse, come su spiegato.
Buongiorno Andrea. Ho seguito con interesse il tuo intervento, anche perchè ho avuto problemi di condensa interna dopo una ristrutturazione di casa mia. Su un muro in sasso di 40/42 cm, ho posto un cappotto esterno di isoprene di 10 cm. Questo, accompagnato da nuovi serramenti a tenuta, secondo me ha provocato umidità interna e condensa. Sto valutando qualche sistema di ventilazione meccanica da installare. Hai qualche suggerimento? Grazie. Leonardo Tezza (VR)
Ciao Luca, i materiali che hanno buoni livelli di effetto tampone sono quelli ad alta densità e media densità nonchè a celle aperte. Ad esempio intonaci in terra cruda, intonaci a calce e cocciopesto, intonaci a calce e canapa, pannelli in terra cruda, pannelli in fibra di legno rasati con terra cruda, ecc..
I benefici di questi materiali ci sono anche dal punto di vista della gestione dei picchi di temperatura superficiale (vedi capacità termica areica interna periodica elevata).
Progettando bene l’utilizzo di questi materiali, abbinati magari alla ventilazione naturale, potrebbe anche farti evitare la ventilazione meccanica.