Il tema del raffrescamento passivo, seppur di attuale interesse, deve sovente confrontarsi con l’aspetto legato alla progettualità del sistema di climatizzazione del fabbricato. Il concetto di Kalte Haus che esprime, in linea teorica, il raffreddamento passivo, non può esimersi da quelle che sono le condizioni al contorno sul funzionamento dell’impianto termotecnico.

Un lettore pone la seguente domanda sul tema del “raffrescamento geotermico a bassa entalpia di tipo passivo” (senza uso di Pompa di Calore):
<< Vorrei sapere se “concettualmente”, senza utilizzare una PDC, ma tramite una sonda geotermica (PP DN25/32) verticale a “U” di idonea lunghezza (in modo che il terreno abbia temperatura costante durante l’anno), collegata in superficie al circuito primario (quello in cui scorre, azionato da un circolatore, il fluido vettore freddo contenuto nella sonda geotermica a “U” che forma un circuito chiuso) di uno scambiatore di calore (es. a tubi concentrici di idonea lunghezza e con idoneo coefficiente di scambio termico), è possibile rimuovere 2 - 3 kW di calore da un fluido vettore caldo (es. acqua/glicole) che scorre, tramite un circolatore, nel circuito secondario dello scambiatore di calore.
Nel caso sia concettualmente possibile, lo scambiatore di calore, per esempio a tubi concentrici del tipo “acqua-acqua” (coefficiente di scambio di almeno: 850 W/mqK), sarebbe di dimensioni contenute (es. lunghezza dell’ordine del metro) oppure ci vorrebbe un capannone industriale per contenerlo? >>
Di seguito i dettagli della risposta:
Quando si progetta un sistema di raffrescamento passivo, una grande variabile da considerare è la latitudine. Non sempre le condizioni climatiche esterne, sia estive, sia invernali, consentono di realizzare quelle che sono le regole applicative del concetto di raffrescamento passivo.
Il quesito già pone condizioni progettuali che a monte possono far pensare ad una portata massima di progetto (giacchè si è indicato un diametro massimo DN 32). Da dire inoltre che la temperatura dell’accumulo terrestre raramente soddisfa le condizioni di isotermia durante il susseguirsi delle stagioni.
Per le logiche impiantistiche di riferimento degli impianti geotermici a circuito chiuso come quelli indicati nel quesito, il gradiente termico (°C/ml) può subire delle variazioni sensibili al variare della località, della latitudine e della situazione geologica del sito.
Un impianto geotermico passivo e quindi senza l’impiego di una macchina elettrica come la Pompa di Calore, può dare risultati interessanti nel soddisfare determinate condizioni di temperatura interna per il comfort ambientale, ma subisce delle limitazioni sulla natura dei carichi termici sui quali insiste.
Per esperienza personale e con limiti di costo dell’impianto posto dalla committenza ho ottenuto buoni risultati dal punto di vista termico, ma non igrometrico. La psicrometria rende noto il legame tra temperatura interna e titolazione del vapor acqueo presente nell’aria fissando le condizioni ottimali di raggiungimento dell’equilibrio temperatura-umidità.
In sostanza il raffrescamento passivo potrebbe ottenere discreti risultati dal punto di vista dei carichi termici sensibili, ma non dal punto di vista dei carichi termici latenti. Non sempre sussiste però la necessità di intervenire su quest’ultimi.
Le sonde geotermiche a singola U o a doppia U con l’impiego di una soluzione acqua/glicole (con calore specifico certamente maggiore di quello dell’acqua), accoppiate ad una camicia di calcestruzzo rinforzato con bentonite, consente di ottenere interessanti prestazioni dal punto di vista dell’asportazione di calore dagli ambienti interni.
La sonda singola o doppia, adeguatamente dimensionata con delta T termico fissato, condizioni geologiche note e quindi profondità ottenuta da metodi analitici, potrebbe per una casa ben isolata nelle sue frontiere scambianti rappresentare la copertura massima del carico sensibile estivo.
Ritengo inoltre che per la separazione idraulica tra circuito primario (geotermico) e circuito secondario (di raffrescamento), sia meglio indicato uno scambiatore a piastre saldo brasato in rame ma in titanio e non acciaio. Per logica impiantistica legata alla manutenzione sovente si utilizzano quelli ispezionabili in luogo dei compatti. Le dimensioni, generalmente essendo costituiti da piastre ad altezza e base prefissata, sono dell’ordine delle 15 – 20 ogni 3 kW di calore asportato, per una lunghezza termica del pacco di piastre sul metro (e per un’altezza di 80 – 100 cm).
Ovviamente, se l’impianto deve sopperire anche al fabbisogno di raffrescamento per carichi latenti, le condizioni progettuali variano e in tal caso non è detto che sia sufficiente una sola sonda geotermica e quindi anche le dimensioni dello scambiatore di calore potrebbero variare.
Le considerazioni fatte per la risposta del lettore partono da elementi di progetto dello scambiatore standard, invero fattore di sporcamento basso, delta T logaritmico tra circuito primario e secondario 5 – 7 °C e perdite di carico sul circuito primario non superiori ai 3 – 5 ml, giacchè queste ultime condizionano notevolmente le prestazioni della pompa sul circuito geotermico.
A cura di Ing. Gennaro Vietri
Photo credit: vizpix


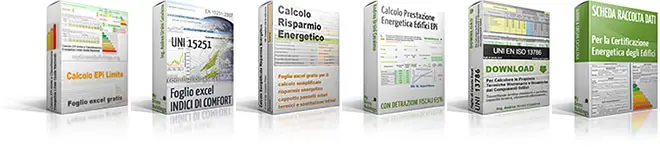
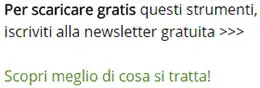






Salve,
nell’ambito del raffrescamento passivo mi permetto di segnalare l’utilizzo di macchine per la ventilazione interna dotate di recuperatore, ormai imprescindibili nelle costruzioni di classe energetica elevata, la cui aria di adduzione dall’esterno venga preraffrescata attraverso pozzo canadese (o detto anche pozzo provenzale); questa soluzione permette di abbattere notevolmente i costi anche se è chiaro che va valutata in base alle carattertistiche dell’abitazione.
In ultima analisi, un’altra valida alternativa, anche se non completamente passiva, è l’utilizzo di recuperatori d’aria già dotati di pompa di calore all’interno, in grado di sfruttare il calore latente presente ancora nell’aria di viziata in espulsione.
http://www.rceenergia.com/1/post/2011/03/la-geotermia-a-basso-costo.html
Buongiorno.
Vorrei chiedere alcuni chiarimenti sulla risposta dell’ing. Vietri:
giustamente è lecito aspettarsi differenti prestazioni e gradienti a seconda delle località e delle tipologie e stratigrafie del terreno nonchè della presenza d’acqua dove s’intende installare la/le sonde termiche.
Però a differenza degli impianti che utilizzano le pompe di calore che lavorano sul lato evaporante a temperature ben inferiori a quelle di congelamento dell’acqua non ho capito la necessità di utilizzare del fluido vettore additivato con antigelo e visto che sia il circuito primario che quello secondario sono chiusi e che il posizionamento nel sottosuolo dovrebbe comunque preservarne l’integrità dal gelo invernale; neppure quella di dotare l’eventuale impianto di uno scambiatore di calore, le cui dimensioni e costo sarebbero prossime a quelle di una p.d.c. che nelle intenzioni del richiedente vorrebbe evitare.
Fosse forse l’esigenza a tutelare l’impianto interno da inconvenienti derivanti dall’eventuale ossigenazione dell’acqua circolante in sonde termiche di PE non dotati di opportuna schermatura EVOH? Nel caso non sarebbe più economica la scelta di un più adatto materiale?
Inoltre graverebbe l’impianto di un consumo di energia extra per la necessità di una seconda pompa di circolazione e che comunque entrambe, dovendo necessariamente garantire un bassissimo dT, quindi portate e prevalenze relativamente elevate, sarebbero particolarmente energivore. E se nel caso, perchè l’impiego di uno scambiatore con piastre in titanio salvo in presenza di acque marine o comunque particolarmente aggressive?
Mi resta comunque il dubbio che di fronte a una richiesta di una potenza complessivamente modesta (3 kW), si perda forse di vista il rapporto tra costi e benefici nel quale una piccola pompa di calore aria/acqua come pure aria/aria sarebbe forse più conveniente.
Ciao Andrea,
in linea teorica è fattibile in pratica, alle nostre latitudini (per capirci in zone climatiche a-b-c-d), non ne vedo l’utilità in termini di prestazioni energetiche e di ritorno economico dell’investimento, è più fattibile una normale pompa di calore aria-aria o aria acqua.
Per Paolo.
L’impiego di soluzioni glicolate sulle sonde geotermiche, incontra sovente opinioni discordanti da parte degli operatori, anche se dal punto di vista tecnico la capacità termica specifica rispetto all’acqua è certamente maggiore (anche se in diluizione).
Qualcuno poi si preoccupa del fatto che in caso di perdite locali, il fluido tossico vada a inquinare falde freatiche di dominio pubblico. E’ una considerazione che rientra certamente nell’ordine naturale del progettista e forse anche prima dell’utente finale.
Da dire inoltre che l’acqua come fluido termovettore costa meno della soluzione glicolata. Pompe di calore condensate ad acqua per impieghi geotermici a circuito chiuso sono certamente più prestanti di quelle condensate ad aria che come ben credo tu sappia hanno il pbm dei cicli antisbrinamento (anche se in qs ultimi anni i costruttori stanno facendo sforzi notevoli per abbassare tale temperatura di soglia. Vedi E-transfer, Waterkotte, IDM).
Spesso negli anni precedenti mi è capitato di vedere pompe di calore condensate ad aria andare durante il periodo invernale di maggior fabbisogno e durante la notte in ciclo protettivo creando carenza termcica all’interno degli ambienti.
Relativamente alla presenza o meno dello scambiatore direi che l’aspetto è legato in genere anche alla configurazione della macchina stessa. Pompe di calore geotermiche di marche note hanno già la separazione idraulica al loro interno, altre no. Il titanio è da impiegare giacchè gli impianti geotermici come hai indicato possono essere anche a ciclo aperto (pozzi freatici, acqua di mare, pozzi, etc etc) per i quali data la natura aggressiva del fluido, una separazione adeguata sarebbe obbligatoria.
Troppe volte ho visto scambiatori impiegati su circuiti chiusi ove sembrava dentro ci fosse acqua, scoprire con sorpresa che poi in realtà erano peloidi minerali che mi han fatto aprire le saldature dello scambiatore come i petali di una margherita (scambiatori in acciaio inox aisi 361 L a saldobrasatura forte in rame). Come hai descritto, se poi si andasse a fare il bilancio energetico totale delle pompe di circolazione anche a basso consumo, un loro debito energetico lo provocano.
I 3 kW di esempio scambiati su circuito chiuso geotermico hanno dei costi certamente superiori ad altri esempi applicativi con pdc condensate ad aria (che costano meno) e che non richiedono interventi invasivi (anche se limitati) di perforazione locale (estremamente costosa). Posso essere d’accordo con te che se si facesse un’analisi costi/benefici a causa dell’elevato costo degli impianti geotermici, forse in svariate occasioni il gioco non varrebbe la candela. Questo almeno è il mio punto di vista.
Se la sonda geotermica ha una profondità sufficiente, circa 100 m, la temperatura del fluido è spesso troppo bassa per evitare la condensazione superficiale sul pavimento. Occorre quindi una regolazione sullo scambiatore, che in base alle condizioni microclimatiche interne, gestisca la temperatura del fluido secondario che circola nel pavimento radiante.
La potenza di raffrescamento è limitata, max 35-40 W/mq, e ovviamente peggiora le condizioni igrotermiche. Diminuendo la T senza deumidificare aumenta il valore di UR.
Per esperienza posso però dire che alcuni benefici sono ottenibili, ma deve essere spiegato molto molto bene che si otterrà solo un modesto raffrescamento, rispetto alle condizioni esterne. Quanto più il clima è caldo-secco e tanto maggiori saranno i benefici
Non va bene per chi vuole il condizionatore a manetta!
In realtà, mantenendo l’impianto in funzione 24 h/gg, si ottiene un positivo effetto di scambio radiante fra il corpo umano e il pavimento freddo e la sensazione percepita è piacevole.
Non va assolutamente bene in ambienti umidi.
Buongiorno
Se lo si deve fare apposta, per fare un po’ di preraffreddamento e/o preriscaldamento, costa un patrimonio.
Va visto come opportunità di utilizzo intelligente nelle stagioni intermedie quando l’impianto già esiste per altri motivi.
Per non parlare delle incertezze sulle stratigrafie del terreno profondo.
Tutte buone idee ma il grosso del problema non lo si risolve così.
Salve Andrea.
Concordo con l’eventuale utilizzo di un pozzo canadese come alternativa alle sonde geotermiche.
Comunque sia la progettazione di questo impianto deve essere molto accurata. Per esempio la profondità delle tubazioni. Queste devono essere a circa 3,6 metri sotto il suolo per sfruttare al meglio l’inversione termica. Diametro e lunghezza calcolati per trasportare e in maniera costante i volumi d’aria necessari per il raffrescamento.
Per il controllo dell’umidità, l’ultimo tratto, ma non meno lungo, potrebbe essere costituito in laterizio, da consentire l’eliminazione dell’umidità eccessiva.
Concettualmente penso che sia realizzabile. Mescolando tra loro i concetti di come si trasmette il calore, inerzia termica dei materiali e scambio energetico tra i fluidi vettori, credo ci sia ancora margine per l’innovazione.
Caro Andrea, parliamone bene.
Entrano in gioco anche fattori non ponderabili (o meglio costosamente ponderabili) ad esempio la temperatura dell’acqua di falda, se c’è.
In linea di principio, vista l’esperienza su impianti installati è meglio un gruppo frigo o una pompa reversibile (per taglie piccole le terra-acqua/acqua non lo sono nella maggioranza dei costruttori).
Nello specifico, se già esiste l’impianto, si tratta di capire com’è, come è stato originariamente progettato? ecc.
Com’è la casa da raffrescare…
A mio avviso la risposta fornita è corretta, ad ogni modo ormai che faccio la sonda geotermica, la pompa di calore la devo comunque installare per l’impianto di riscaldamento (altrimenti il costo della sonda geotermica lo ammortizzo in tempi troppo lunghi).
Inoltre utilizzando la sonda geotermica una sola stagione, con il passare del tempo, la temperatura nel pozzo geotermico varia (nella fattispecie aumenta) rendendo meno efficiente l’impianto.
Ho realizzato 5 anni fa un sistema geotermico passivo che attualmente funziona, anzi l’estate hanno bisogno di mettersi anche un lenzuolo per coprirsi.
Comunque la tua risposta ha centrato il problema, ovvero la riuscita di un tale sistema dipende fortemente dalle condizioni al contorno.
Il mio caso di studio è costituito dai seguenti parametri:
– acqua di falda alla profondità di m 25 circa;
– temperatura compresa tra 16 e 17 gradi centrigradi;
– possibilità di evitare il corto circuito della falda di scambio termico;
– installazione di una pompa azionata da un sistema ad inverter collegato alla sonda termica in modo da modulare la portata di fluido;
– eliminazione dello scambiatore a piastre ma immetto direttamente il fluido nei termovettori;
Risultati ottenuti che riesco a condensare tranquillamente (sottrarre il calore latente) con una potenza assorbita dalla pompa di circolazione comnpresa tra 300 e 500 W.
Mediamente riesco ad abbassare la temperatura sensibile all’interno di 4/5 gradi cenigradi.
Saluti
Ing. Vietri
Una cosa, che ti resta a ronzare in testa, una di quelle che hai dato per scontato un’era fa’ e non ti sei più preoccupato di verificarla fin quando non si torna sull’argomento, magari come in questo caso, a dire il contrario di quanto si è sempre supposto.
Mi riferisco alla frase:
“… con l’impiego di una soluzione acqua/glicole (con calore specifico certamente maggiore di quello dell’acqua”
poi successivamente ribattuta e rafforzata
“… anche se dal punto di vista tecnico la capacità termica specifica rispetto all’acqua è certamente maggiore (anche se in diluizione)”
Ciò come ho già detto scornava con le mie nozioni, tra le quali ricordo le tabelle di resa delle macchine frogorifere, dove l’impiego di miscele glicolate penalizzava i rendimenti a causa del peggior scambio termico.
Per “tagliare la testa al toro” ho quindi cercato conferma trovando infatti che, salvo liquidi “spaziali”, l’acqua pura è il fluido vettore con il calore specifico più elevato 4,186 kJ/kg*K.
Le miscela con glicole etilenico, già a partire dal 10%, abbassano questo valore a circa 3,9 KJ/Kg*K; al 30% siamo 3,55 KJ/Kg*K mentre al 50% di miscela “precipitiamo a meno di 3,1 KJ/Kg*K. Va un po’ meglio con il glicole propilenico ma resta sempre un peggiorativo rispetto all’uso della sola acqua. Inoltre peggiora pure la viscosità penalizzando così il lavoro delle pompe solo in parte compensato dall’aumento della densità.
Dove sta’ l’inghippo o l’incomprensione?
La cosa mi solletica fin da quando ero ragazzo e concordo con chi per primo ha posto la domanda lungo tempo, ma, dopo aver letto gli interventi, sento il dovere di precisare qualcosa: mordiamo il freno e andiamo per ordine.
Se il genio Civile (settore che i occupa dei pozzi e della falda) viene a sapere che qualcuno immette nel sottosuolo dei gas frigoriferi o del glicole etilenico, (non dimentichiamo che il vicino di casa che ha un pozzo per acqua, eventualmente legalmente potabile o per uso domestico o animale ha diritto di non vederselo inquinato all’improvviso da una nostra perdita), scatena giustamente tutti i Carabinieri della contea.
Ok, usiamo un doppio circuito, secondario ad acqua potabile chiuso con quantità controllata così, in caso di perdita, in falda ci va solo l’acqua del circuito secondario. Vaso di espansione monitorato in pressione e livello, sì da bloccare automaticamente eventuali perdite.
Ovviamente la parte interrata sarà ispezionabile e sostituibile (incamiciata in tubo antischiacciamento, salita e discesa eventualmente coassiali, dice il nostro amico, nello stesso pozzo-camicia allagato di acqua di falda) con tubo inox, alluminio o materiale plastico ad alta trasmittanza termica (€€).
In che terreno dobbiamo scavare? Roccia (€€€) o sabbia (€); a che profondità? Con che sismicità? Vi sono vincoli idrogeologici? Vi è pendenza, con relativa possibilità di innesco di smottamenti?
Tutto questo va scritto nel progetto autorizzativo da presentare alle Autorità che presiedono all’ambiente, per il quale bisogna pagare, oltre ai costi di scavo e posa d’impianto.
Ok, ci hanno autorizzato, abbiamo pagato ingegnere e geologo e abbiamo preventivato un bel pò di soldi da spendere .
Ora possiamo finalmente accedere alla domanda originale, la cui risposta adesso è ovvia: dopo aver speso tutti quei soldi, l’efficienza deve essere massima: Pompa di calore, taglia significativamente “robusta”, tale da soddisfare un piano di rientro del capitale attraverso i risparmi energetici, traguardando una ipotesi di mutuo.
Ne vale la pena? Si, per un albergo isolato, un grosso insediamento (ospedale, etc.) .
Per una casetta vi sono 2 strade: rinunciare o saltare a piè pari tutte le considerazioni precedenti, rischiando una denuncia penale (mi candido per firmarla io).
Cordiali saluti. R. Ravera
Per Paolo,
l’inghippo sta nel fatto che volevo trasmettere velocemente un concetto sull’impiego del tipo di fluido termovettore senza entrare nella specificità delle loro caratteristiche. :-)
Relativamente all’impiego di acqua o glicole o soluzione dioliche, giacchè i dioli in realtà sono più comunemente noti con il termine di glicoli (1-2; 1-3; 1- etc etc per i composti a base organica in cui compaiono gli alcani e che prendono i nomi comuni conosciuti) se ne affiancano altri con componenti in fase non propriamente liquida o pseudoliquida che possono far aumentare, rispetto alla semplice acqua in condizione di saturazione e a temperatura e pressione di riferimento, il calore specifico del fluido termovettore.
Io stesso sto confrontando dei risultati su alcuni test con un fornitore di sonde geotermiche non italiano, di resa specifica su sonde a singola U che impiegano come fluido termovettore non acqua, ma una soluzione all’interno della quale in titolazione preponderante non c’è più glicole, ma altro e con calore specifico maggiore della semplice acqua :-) e forse lo hai anche intuito visto che parli di “fluidi spaziali”…
I risultati mi sembrano incoraggianti. Nell’articolo mi son lasciato trasportare dall’entusiasmo ed ho forse prematuramente lasciato scappare questo concetto.
In fase non liquida, come ben sai, altre soluzioni sono al vaglio dei fornitori di pompe di calore geotermiche, ma che a mio avviso non usciranno sul mercato a breve. Forse le vedremo tra qualche ISH.
Ciao Andrea,
ecco cosa ne penso sul geotermico.
– La geotermia non conviene per edifici di vecchia generazione.
– Ha un costo attuale troppo elevato.
– Ogni luogo, con le sue caratteristiche climatiche e geologiche, necessita di particolari attenzioni progettuali.
– L’installazione di un impianto geotermico in un contesto costruito già esistente è piuttosto difficoltoso: in aree ad alta densità abitativa può essere addirittura impossibile e non bisogna dimenticare che l’operazione di trivellazione, oltre che costosa, necessita anche di spazio. In ogni caso, per l’utilizzo di un impianto geotermico, come detto, sono necessari terminali a bassa temperatura: i classici “caloriferi”, ventil convettori, vecchi impianti a pavimento, etc. sono invece ad alta temperatura (lavorano a 65-70°), e in loro presenza il risparmio sarebbe vanificato.
– E’ consigliabile adottare la geotermia in nuove costruzioni o ristrutturazioni complete. Anzi a mio parere nei nuovi interventi dovrebbe, (con l’aiuto di buoni incentivi) addirittura divenire un “obbligo”, insieme a solare termico e fotovoltaico.
– Se si è in una buona classe energetica (almeno in B), l’impianto geotermico è quasi sicuramente sufficiente a riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria per abitazioni di qualsiasi metratura, basta che il suo dimensionamento sia corretto.